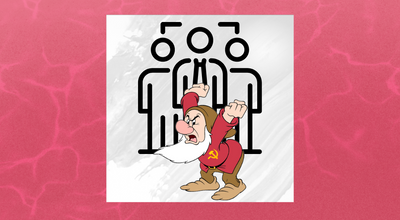Oggi – tanto per cambiare – facciamo un discorso complicato, che orbita attorno a una delle fatiche più erculee dell’umanità contemporanea: il distinguo. È in corso, lo saprai, l’80ª edizione della Mostra del cinema di Venezia. Ci sono i tanti film in concorso e fuori, le passerelle, i voti agli “outfit” dei giornali e degli influencer e insomma, le solite altre amenità del caso.
Ma poi ci sono anche le contestazioni, le polemiche, le ferite aperte. Una in particolare, popolare nelle nicchie social, in forma scritta recita più o meno così: ehi ragazzi, vi pare giusto che la Mostra del cinema di Venezia venga consacrata ai pedofili? No, dico, lo sapevate che hanno invitato un gruppetto di uomini anziani che toccano i bambini a presentare i loro film?
Capisco la provenienza di queste critiche, in parte la condivido, ma il grosso limite che hanno è quello di fare di tutta l’erba il proverbiale fascio, accorpando carnefici e accusati, e riducendo vicende complesse e opache a condanne sbrigative virali. Forse se non l’avete sentito, che Venezia omaggia una cricca di pedofili, è perché, nonostante quel che si dice su X/Twitter, non è del tutto vero.
Quella del contestato Woody Allen è una brutta storia su cui da trent’anni grava una cappa di dubbi, pronunciamenti e testimonianze che non lasciano spazio a nessuna certezza. Spesso si è parlato, in relazione a questo caso, di cancel culture: eppure il regista stesso ha detto che non sa cosa significhi venire “cancellato”, e di certo non ha smesso di fare film e vivere la sua vita da milionario newyorkese.
Nel frattempo in questi giorni in Laguna è approdato anche un vero, acclarato sex offender, che decenni fa si è dichiarato colpevole di aver violentato una tredicenne e ha ammesso, anzi rivendicato di essere attratto dalle ragazzine di quell’età: è il regista Roman Polański. Ogni iniziativa di protesta nei confronti della sua presenza è, per quel che vale il mio parere personale, più che legittima e ben motivata (qualche mese fa l’attrice francese Adèle Haenel aveva annunciato il suo sciopero contro la compiacenza del settore verso i predatori sessuali come Polański).
Il caso Woody Allen invece lo conosco – bene – da anni, è profondamente diverso, e non è chiaro a chi o cosa giovi renderlo parte di un polpettone unico: se Polański è stato condannato ed è addirittura fuggito all’estero per non essere processato, Allen vive a Manhattan da sempre, e nessun tribunale, centro di violenza sui minori o psicologo ha mai confermato nessuna delle accuse che pendono sul suo capo. Attribuirgli persino che «si scopa» la fu figlia adottiva Soon-Yi Previn – come ho visto fare fin troppo in questi giorni – sorvola sul fatto che i due stanno insieme da trent’anni e hanno due figli: sì, la relazione è di certo inconsueta, ma saranno pure fatti loro, no?
Per una volta giova rimandare alla lettura della pagina Wikipedia in lingua inglese dedicata al caso, che è completa e precisa: sfido chiunque ad arrivare in fondo pensando in buona fede “questa canaglia l’ha fatta franca”. E non perché la sua innocenza sia cristallina e indubitabile, ma perché – repetita iuvant – tutti coloro che avrebbero potuto e dovuto accertare la sua colpevolezza non l’hanno fatto: tribunali, periti, esperti di violenza sui minori, psicologi, consulenti, collaboratori domestici di casa Allen-Farrow. Soon-Yi e il fratello Moses Farrow, se è per questo, hanno dichiarato che è stata la loro madre adottiva Mia Farrow, e non Woody Allen, ad abusare di loro.
Sì, ho visto il documentario Hbo Allen v. Farrow; sì, ho letto i diversi interventi negli anni di Dylan Farrow, l’altra figlia, quella che ha dichiarato di essere stata abusata da Allen e che all’epoca dei fatti aveva sette anni e viveva in una famiglia altamente disfunzionale; no, non sono sicuro di niente, se non del fatto che di sicurezze in questo caso non ce ne sono, appunto. Riporto un commento apparso sotto l’editoriale difensivo di Allen pubblicato dal New York Times nel 2014:
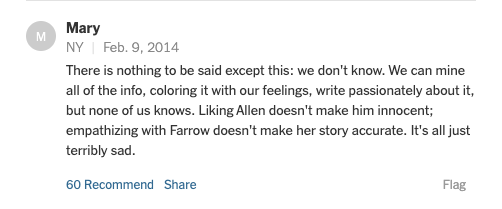
Non elevo Woody Allen a esempio morale, a eroe, men che meno a vittima, ma mi spaventa che le piattaforme digitali della comunicazione di oggi direzionino l’attivismo sostituendo metodicamente all’approfondimento dei casi e delle situazioni una verità di vulgata precotta, che non ha tempo da perdere dietro ai “se” e ai “ma”: se tutti quelli che leggo scrivono che è un pedofilo, vergogna!, quello è un pedofilo. (E poi «si scopa» la figlia adottiva, no?).
Senza troppi sforzi, si possono trovare sul fu Twitter i commenti di chi ha partecipato in prima persona alla contestazione di Allen a Venezia, vantandosi di aver inferto un colpo alla rape culture. Ma del rape del regista di Manhattan non sappiamo nulla di più di ciò che vogliamo convincerci di sapere, e farne un altro esempio certo e indubitabile di tossicità da additare – fregandosene delle prove, delle perizie, degli effetti che quest’approssimazione ha sulle persone meno potenti di Woody Allen e sulla capacità persuasiva delle cause più nobili e giuste – non è il futuro sensibile e giusto che auspichiamo: è un passato oscurantista da lettera scarlatta.
E poi c’è Favino

L’altro grande tema della Mostra del cinema 2023 sono le parole del più noto degli attori nostrani, Pierfrancesco Favino, che nella conferenza stampa di presentazione del film Comandante Edoardo De Angelis, di cui è protagonista, e in susseguenti interviste ha dichiarato che il cinema italiano farebbe bene a fare «fronte comune» per far sì che ruoli come quello di Enzo Ferrari – il fondatore della causa automobilistica interpretato da Adam Driver nel Ferrari di Michael Mann – non siano affidati a «stranieri lontani dai protagonisti reali delle storie, a cominciare dall’accento esotico».
Favino ha parlato anche di «appropriazione culturale», chiedendo: «Se un cubano non può fare un messicano, perché un americano può fare un italiano?». È un modo di inserirsi in un dibattito che all’estero è già alle soglie del mainstream da anni (e il riferimento all’«appropriazione culturale», in questo senso, è chiaro). Secondo la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, Favino ha sottolineato «un paradosso»:
In un momento in cui gli americani (e non solo) danno estrema importanza al concetto di autenticità, perché rappresentano storie e personaggi italiani in modo non autentico?
Molti altri hanno spostato il tema sulla debolezza economica e “di sistema” del cinema italiano. Riassumendo questa posizione: Favino fa benissimo a porre il problema, ma sarebbe meglio fare pressione e adoperarsi per dare al cinema nostrano più voce in capitolo a Hollywood.
Qualcuno ha persino definito la sua uscita «una sintesi tra rivendicazioni sovraniste e rivendicazioni woke». Io credo invece che ci sia molto di che parlare, e che lo stiano facendo persone più titolate di me. Ma di «appropriazione culturale» relativa ai film tratto anche io, nel mio saggio La correzione del mondo (Einaudi Stile Libero). Citando:
Se a destra una marea montante di intolleranza e razzismo porta a cicliche polemiche online innescate da una rappresentazione «diversa» dei personaggi della fiction (come dimenticare quelle sulla Sirenetta interpretata dall’attrice afroamericana Halle Bailey nel live action Disney di quest’anno, o quella sugli elfi neri del nuovo adattamento tolkieniano del Signore degli Anelli di Amazon?), paradossalmente anche al di qua delle barricate si generano pedanti dispute pregiudiziali su attori che scantonano oltre i ruoli a loro permessi: perché Bryan Cranston, che non è disabile, ha interpretato un quadriplegico nel film The Upside (2017)? Per quale motivo in Doctor Strange (2016) il ruolo dell’Antico, che tradizionalmente nei fumetti Marvel da cui il lungometraggio è tratto era un monaco tibetano, è andato a Tilda Swinton? Dato per assodato che quella dei conservatori sulla Sirenetta è propaganda bieca e reazionaria, come si fa a opporle una logica simmetrica, per cui quelli appena citati sono esempi inauditi di abilismo e whitewashing da condannare con vibrante indignazione, e non legittime scelte di casting?
Se si accetta il frame discorsivo per cui una «minoranza oppressa» – espressione che online si usa con la generosità e l’approssimazione del sale in cucina, purtroppo per le minoranze e per gli oppressi – può essere rappresentata solo da attori e attrici che ne fanno parte, e in generale che bisogna puntare sull’autenticità (diciamo) della provenienza degli attori, allora Favino ha ragione da vendere: certo, gli italo-americani «oppressi» non lo sono più da tempo, ma perché considerarli al di fuori di queste logiche?
Sottoscrivere questa forma mentis ha delle implicazioni ineludibili, tuttavia: significa che l’Adam Driver di turno farà bene a passare di mano il suo ruolo di Enzo Ferrari non perché c’è una produzione, una proposta, una partizione del cinema in grado di raccontare meglio quella storia, ma perché una regola di forma ha determinato a priori che non è la persona più adatta a recitarla, a prescindere da altre e ben più sensate considerazioni ulteriori (l’accento, gli eventuali stereotipi, eccetera).
A te sembra il viatico migliore per migliorare il cinema italiano? A me non tanto.
Altre news dal fronte
- Il dramma di chiamarsi John Hittler;

- Harvard è tra le peggiori università d’America sotto il profilo del free speech;

- Un ricco sobborgo liberal di Chicago, Highland Park, aveva organizzato (per poi cancellarlo in fretta e furia) un evento di «simulazione di povertà», definito «esperienza immersiva» in un country club, per sensibilizzare sulle condizioni di vita della popolazione indigente.

(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)