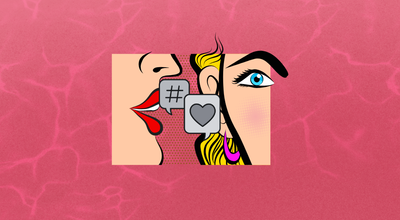Lunedì 20 maggio il procuratore capo della Corte penale internazionale (ICC) Karim Khan si è espresso a favore dell’emissione di mandati d’arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del suo ministro della Difesa Yoav Gallant, del leader di Hamas Yahya Sinwar e di sue due sottoposti, il capo delle Brigate Qassem Mohammed Deif e il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh.
È il culmine di un lavoro legale durato mesi, in cui la procura dell’ente sovranazionale ha vagliato le prove disponibili per concludere che le leadership di Israele e Hamas hanno violato il diritto internazionale e sono da intendersi colpevoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
L’annuncio di Khan non si tradurrà, ovviamente, in un arresto in grande stile dei cinque politici mediorientali (in passato la Corte ha prodotto pronunciamenti simili su Vladimir Putin e Mu’ammar Gheddafi, tra gli altri), ma è il primo vero colpo battuto dalla giurisprudenza internazionale su un conflitto in corso che ha già fatto decine di migliaia di morti innocenti. Ed è un colpo importante, in prospettiva diplomatica.
Tra gli esperti di settore che hanno revisionato l’incriminazione formale dell’ICC c’è Amal Alamuddin – ora meglio nota col suo nome da sposata Amal Clooney – che appare anche tra le firme di un op-ed pubblicato sul Financial Times in cui il gruppo ha spiegato le ragioni dell’esito della sua perizia:
Per mesi ci siamo impegnati in un ampio processo di revisione e analisi. Abbiamo esaminato attentamente ciascuna delle richieste di mandato d'arresto [...] E siamo unanimemente d’accordo sul fatto che esistono ragionevoli motivi di ritenere che i sospettati identificati abbiano commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità all’interno della giurisdizione dell’ICC.
Amal Clooney, ben prima di essere un volto noto della cronaca rosa hollywoodiana, lo era – e lo è – nell’agone del diritto umanitario internazionale: è apparsa davanti alla Corte penale internazionale e alla Corte internazionale di giustizia rappresentando vittime di genocidio armene, del Darfur, ucraine.
Eppure il suo cursus honorum negli ultimi mesi non le ha evitato un profluvio di critiche sui social media. Il motivo? Beh, il non essersi esposta su Gaza. E con «esporsi» qui intendiamo, ovviamente, il pubblicare storie Instagram o tweet sulla tragedia in corso in Palestina.
«Il silenzio di Amal Clooney su Gaza mostra i limiti del liberalismo», tromboneggiava non più tardi del mese scorso questo tizio, tal Alan MacLeod, spiegando che la «liberal icon» e la sua Clooney Foundation for Justice:
Non si tirano mai indietro dal pronunciare i loro verdetti globali sulle questioni relative ai diritti umani. Eppure, nonostante sia di origine libanese e palestinese lei stessa, la Donna dell’anno 2022 della rivista Time ha mantenuto un silenzio completo sui continui bombardamenti di Israele su quei paesi.
Col senno del poi, certo, ma ora sappiamo che mentre lui scriveva articoli come questo e correggeva titoli di CNN in favore di follower, lei era una delle otto persone al mondo che stavano lavorando per porre le basi legali per un mandato di cattura per Netanyahu. Tu vedi a volte i paradossi, eh?
Ho preso un singolo articolo ad esempio, ma Amal Clooney è stata called out, come si dice, per il suo presunto inattivismo da migliaia di utenti, che su TikTok la accusavano di essere «troppo impegnata» per spendere due parole sulla questione (e dunque avevano ragione, in senso letterale).
Trarre a forza un apologo senza pieghe da questa storia sarebbe incauto: non tutti coloro che non si schierano sui massacri in corso fanno parte di un gruppo di lavoro che opera per condannarne i responsabili (anzi, non sono un esperto di statistica ma temo si tratti di un caso raro), ed è ben più che legittimo che il pubblico e gli attivisti facciano pressione perché l’attenzione internazionale rimanga alta, in generale.
Eppure qualcosa la vicenda di Amal Clooney lo mette in chiaro. Per cominciare, che quel che mostriamo sui social media non può e non deve bastare a definire il nostro apporto alle cause che sosteniamo: un tweet al vetriolo o un minuto di video indignato su TikTok, salvo rare eccezioni, hanno l’unico effetto di alimentare un ciclo di engagement e frustrazione che non esce dal recinto di una bolla di opinione pre-costituita.
Anche quando ci illudiamo di stare aiutando qualcuno nel mondo reale – e talvolta succede per davvero, intendiamoci: ma in che percentuale? – in realtà stiamo anzitutto facendo felice un algoritmo.
La radicalità del nostro pensiero e la fermezza delle nostre posizioni, di per sé, non hanno nulla a che vedere con quello che postiamo online: pubblicare un contenuto su internet è la cosa più semplice del mondo, può farlo chiunque a costo vicino allo zero. Ma l’effetto della moltiplicazione di contenuti dell’era dei social non è stata una moltiplicazione analoga della presa sociale e politica delle mobilitazioni: il risultato, anzi, è depotenziato a monte e – 9 volte su 10 – nel caso in questione non ha alcuna conseguenza sui bombardamenti israeliani.
Non significa che unirsi e fare divulgazione politica o attivismo sui social media sia di per sé sempre e invariabilmente vano: il problema, semmai, è che abitiamo una società dove una dichiarazione alla stampa o un commento su Twitter contano più del bene fatto sul campo, del proverbiale sporcarsi le mani per cambiare il mondo, invece di limitarsi a raccogliere like con le sue tragedie e i suoi problemi.
E questo andazzo, insomma, non può portare in un buon posto. La prossima volta che chiediamo a una persona che sappiamo nostra ”alleata” perché non si espone con un post, concediamole il beneficio del dubbio: magari si espone in altri luoghi, fatti di meno engagement e più efficacia. E se è così, prendiamo esempio.
Altre news dal fronte
- Sottogenere delle guerre culturali che mi piace molto: gli elettrodomestici woke (secondo i Repubblicani);

- Mania, il romanzo della critica letteraria Lionel Shriver che immagina un’America dove non si può più dire «stupido» per questioni di correttezza linguistica, pare così così;

- Trovarsi al timone della Tate di Londra di questi tempi? Un vero casino.