È uscito da poco il 2023 Digital News Report, uno dei principali – se non il principale – report sull’informazione globale, compilato dal Reuters Institute of Journalism di Oxford e di grande impatto già soltanto per il suo enorme bacino statistico: 93mila rispondenti di ogni fascia d’età, provenienti da 46 Paesi.
Il Reuters e il suo partner YouGov hanno analizzato e documentato nero su bianco, come si dice, i movimenti tellurici nel nostro rapporto con le notizie. Trovando che a ogni latitudine – e con crescite esponenziali nel Sud del mondo – la dieta mediatica dipende sempre più da un pugno di piattaforme video: Instagram, YouTube, TikTok. Nel contempo, l’elefantiaco e vetusto Facebook prosegue in picchiata la sua china di perdita di influenza.
E poi ci sono gli influencer, sempre più graniticamente centrali nel filtro e nella diffusione delle news, e il dato eloquente per cui il pubblico ripone pressapoco la stessa fiducia nella selezione delle notizie operata dai giornalisti di ruolo e in quella regolata dagli algoritmi (la prima è apprezzata dal 27% dei rispondenti, la seconda dal 30%).
C’è però una parte dei key findings del report di quest’anno che ha catturato la mia attenzione più di questi aspetti. Eccola:
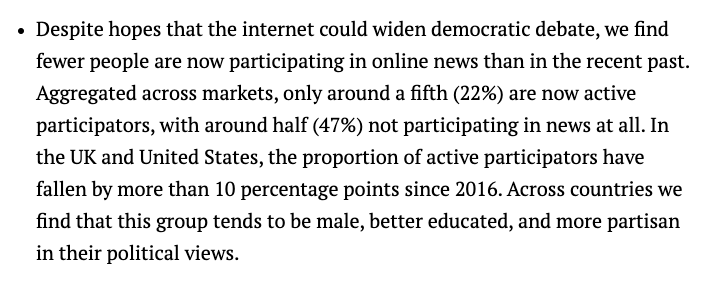
Per i meno anglofoni: «nonostante le speranze» che internet avrebbe allargato la dialettica democratica, sempre meno persone risultano essere parte dei discorsi alimentati dal ciclo delle notizie online. Solo un quinto del totale è considerabile un partecipante attivo al discorso pubblico social-mediato, e addirittura il 47% non vi partecipa affatto.
Non bastasse, due dati freddi e taglienti come coltelli: nel Regno Unito e negli Stati Uniti la proporzione di partecipanti attivi è diminuita di dieci punti percentuali dal 2016. E nel mondo, in generale, l’identikit di chi fa parte di questo gruppo al comando è: maschio, con una scolarizzazione di livello alto e idee politiche faziose e inflessibili.
Beh, sono io o sembra proprio un identikit preoccupantemente simile a quello di coloro che nella storia hanno sempre partecipato? Di chi ha sempre avuto voce in capitolo e carta bianca per orientare i discorsi e le scelte comuni?
Ecco, non è propriamente un dettaglio: abbiamo passato l’ultimo decennio a dirci che le piattaforme, la connessione onnipresente e la viralità globale ci avrebbero restituito un mondo più giusto, e se non più giusto almeno più partecipato. Ma oggi ci ritroviamo a vivere in uno dove parlano gli stessi di prima di internet: quelli che fanno la voce grossa e hanno tempo, modo e risorse per prevalere sugli altri.
Ci siamo illusi che quello che avviene su Twitter o Instagram fosse «passare il microfono agli altri» (per citare una definizione di Claudia Durastanti che utilizzo spesso in senso critico, e me ne scuso con lei), mentre la realtà andava da un’altra parte. Facendo una cosa inelegante qual è citarmi da solo, ne La correzione del mondo scrivo:
Quella dei «nuovi invitati alla festa» del dibattito pubblico a cui «passare il microfono», colpevoli al limite di una «aggressività gioiosa» nel porre le loro istanze politiche e rimostranze sociali, è una versione parziale e profondamente ritoccata di ciò che accade ogni giorno sulle macchine degli algoritmi. Questa presunta responsabilizzazione passa da multinazionali senza alcuna agenda progressista, che in passato non si sono fatte problemi a usare la loro arbitrarietà decisionale contro le minoranze, e induce a concentrarsi sulle manifestazioni superficiali e sui piani simbolici, lasciando da parte ogni considerazione politica più profonda e duratura, nonché qualsiasi possibilità di ravvedimento e persuasione. Questo «passare il microfono» in realtà l’ha lasciato a disposizione degli stessi che l’hanno sempre avuto stretto fra le mani, con poche eccezioni: semplicemente ora cantano un’altra canzone o cambiano la dedica.
Mentre scrivevo il libro non avevo a disposizione gli ultimi dati del Digital News Report, ovviamente, ma sapevo – come so tuttora – che nell’internet attuale «tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi» (qui invece cito Marracash), e che la nostra comunicazione globale è appaltata da un decennio a multinazionali opache e in cerca di engagement che abbiamo scambiato per veicoli di progresso sociale.
Come ha spiegato il filosofo di origine nigeriana Olúfémi Táíwò in un suo bel saggio, sui social odierni persino gli appartenenti nominali a una minoranza finiscono per non coincidere affatto con le persone di cui vorrebbero fare le veci: essere nella stanza degli specchi socialmediali oggi significa avere più tempo libero a disposizione e una maggiore padronanza di codici linguistici, oltre a una scolarizzazione elitaria e un ceto di appartenenza più alto.
Quando leggi qualche influencer che, magari per giustificare questo o quello, dice di lottare per le minoranze che rialzano la testa su Twitter, sappi che le minoranze, con poche eccezioni, non sono su Twitter. E, detto francamente, che non ci serve un altro influencer nelle vesti di buttafuori di un club privato: vogliamo l’ingresso libero per tutti e per tutte, in un posto aperto e felice.
«La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione».
Altre news dal fronte
- Avrai letto della brutta storia delle molestie seriali, anzitutto tramite tremenda chat di gruppo, dalle parti della grande agenzia pubblicitaria We Are Social: a me ha colpito anzitutto che la prima denuncia di questo #MeToo dell’advertising risale a gennaio del 2020, cioè a più di tre anni fa. Perché nessuno ha approfondito prima queste storie? E mi ha colpito anche molto il profilo di Monica Rossi – lo pseudonimo dietro cui si cela l’intervistatore da cui è nato il caso di questi giorni – che ha pubblicato un post in cui dice di aver scelto di non pubblicare una nuova intervista perché «ci sono già troppe persone che si vogliono fare portavoce di un movimento che vorrebbe mettere insieme cose diversissime fra loro e che mi chiedono di mettermi "a disposizione" per fare come dicono loro»;

- Ahi ahi, anche gli investimenti sostenibili sono entrati nel ping pong mediatico-istituzionale delle guerre culturali;

- Breve storia dell’affirmative action in America (è il nome che si dà a quel complesso di norme e regole che facilitano l’ammissione di persone appartenenti a minoranze nelle università), che potrebbe finire quest’estate.

(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)









