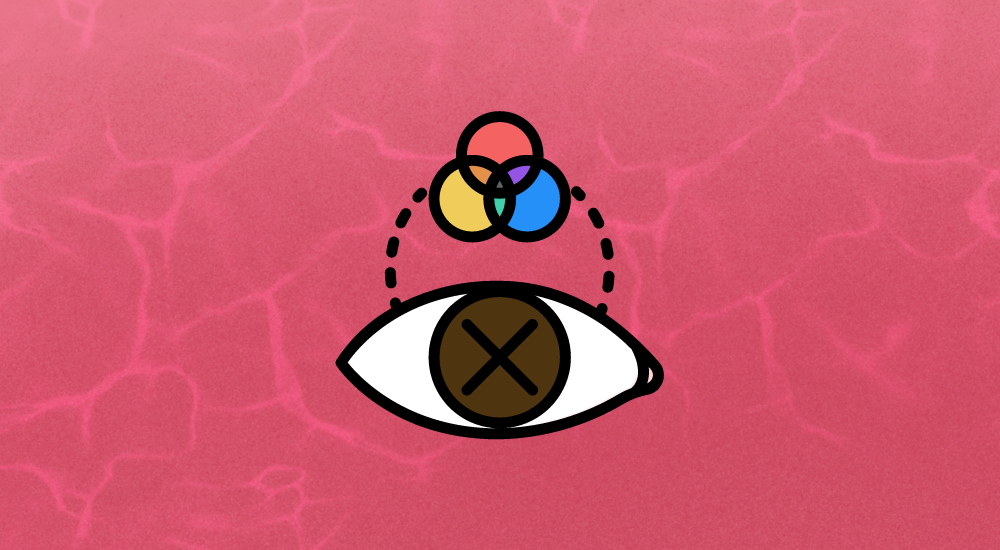Coleman Hughes è un giornalista e scrittore afroamericano di origini portoricane. Gli interventi di Hughes – che nel 2019 è intervenuto al Congresso americano schierandosi contro le reparations, cioè il sistema di proposte per risarcire economicamente i discendenti delle vittime della schiavitù ai danni dei neri americani – sono ospitati anche da testate conservatrici come Quillette, il Wall Street Journal e la National Review.
Nelle ultime settimane, però, di Hughes si è parlato in riferimento a un Ted Talk: quello che ha registrato alla conferenza annuale Ted a Vancouver lo scorso aprile e che ha fatto scoppiare un caso. Il tema dell’intervento è la color blindness – ovvero l’approccio, di cui Hughes è fautore, che non vuole che l’appartenenza etnico-razziale risulti il fattore dirimente nella definizione delle politiche pubbliche e dei rapporti sociali – e la vicenda è stata raccontata dallo stesso autore in un articolo uscito su The Free Press:
Come potete immaginare, Ted è una macchina straordinariamente ben oliata. Nelle settimane e nei mesi precedenti la conferenza ho scritto il mio discorso, l’ho rivisto insieme al team di curatori di Ted e i loro fact-checker l’hanno passato al setaccio. Non mi sono mai preparato così tanto per uno speech. Il 19 aprile sono salito sul palco davanti a un pubblico di quasi 2.000 persone e l'ho recitato.
Hughes aggiunge che, a parte qualche parere contrario, alla fine della sua orazione «l’accoglienza è stata estremamente positiva. Il pubblico ha applaudito; alcuni si sono addirittura alzate in piedi. A cena e nei corridoi, le persone mi si sono avvicinate per dirmi che il discorso gli era piaciuto, e coloro che non erano d’accordo mi hanno fatto critiche intelligenti e ponderate».
Ma, come hai capito, era soltanto il tempo sereno prima della tempesta. L’ultimo giorno della kermesse, a un tradizionale confronto à la town hall in cui il pubblico può esprimersi sui contenuti della conferenza, due persone hanno denunciato il discorso di Coleman Hughes con parole scandalizzate e altisonanti: una donna l’ha definito «razzista»; un uomo ha detto che Hughes aveva proposto di «tornare ai giorni del “separati ma uguali”». Molti hanno applaudito.
Ancora più interessante è ciò che è successo dopo: Chris Anderson, il capo supremo di Ted, che sulle prime, durante l’assemblea finale di Vancouver, aveva preso il microfono per ricordare al pubblico che «Ted non può sottrarsi alle controversie su questioni così importanti», in un secondo momento ha contattato Hughes per spiegarli che il suo intervento aveva attirato «resistenze» interne all’organizzazione, e che una parte dello staff era convinta che Ted non avrebbe dovuto pubblicarlo.
Molto del risentimento e della richiesta di ritirare il contenuto, adduceva Anderson, veniva da Black@Ted, che si definisce «un gruppo delle risorse umane che fornisce un safe space ai dipendenti che si identificano come Neri». Hughes racconta che il capo di Ted gli ha chiesto se volesse incontrare queste persone: lui, secondo la sua versione dei fatti, ha detto di sì, per poi scoprire subito dopo che il gruppo, per motivi a lui ignoti, aveva ritirato la sua disponibilità a incontrarlo.
In seguito, Anderson ha fatto una serie di proposte insolite al suo ospite: prima ha chiesto a Hughes di accettare la pubblicazione del video del discorso in una versione accorpata a un susseguente dibattito da sostenere con persone di posizioni anti-color blindness (Hughes ha rifiutato); poi gli ha proposto di registrare il dibattito in un altro video, suggerendo che questo avrebbe dato ulteriore spazio alle idee di Hughes (il quale, non essendo nato ieri, ha rifiutato ancora).
Alla fine le due parti hanno trovato un accordo: ci sarebbe stato un dibattito, ma sarebbe avvenuto due settimane dopo la normale pubblicazione e sponsorizzazione del Ted Talk. Hughes tuttavia sostiene – e qui anche i numeri confermano che lo fa correttamente – che il suo discorso è rimasto per settimane in un cono d’ombra, e che l’organizzazione non ha messo in moto la sua nota e potente macchina per promuoverlo, come ha sempre fatto negli altri casi.
Volendo vederci chiaro – ed essendo, teoricamente, un giornalista – ho deciso di ascoltare integralmente l’intervento della discordia, che nonostante tutto si trova su YouTube. Non tanto sorprendentemente, non ci ho trovato davvero nulla di incendiario, nemmeno a voler vedere del marcio a tutti i costi, neanche dando per scontato che l’oratore agisca e parli col grado massimo di malafede nascosta.
Nel suo Ted Talk, Coleman Hughes ricorda che il primo a usare l’espressione color blindness fu Wendell Phillips, attivista per l’abolizione della schiavitù nell’Ottocento e presidente della American Antislavery Society; spiega che, secondo lui, «eliminare le politiche sulla base della razza non equivale a eliminare le politiche per ridurre le disuguaglianze. Significa soltanto che quelle politiche dovrebbero essere messe in atto sulla base della classe, non della razza». Verso l’inizio, riassume il suo messaggio in:
Sostenere la color blindness non significa fingere di non notare la razza: è sostenere il principio secondo cui dovremmo fare del nostro meglio per trattare le persone a prescindere dalla loro razza, sia nella nostra vita personale che nella nostra politica pubblica.
Non pare così «razzista» come messaggio, dopotutto, specie considerando che a sostenerne una versione identica nella sostanza era un reverendo afroamericano autore di un altro discorso, appena più noto, che oltre a «I have a dream» diceva di immaginare un’America in cui le persone «non sono giudicate per il colore della loro pelle ma per il contenuto del loro carattere».
Quell’America è lontana dal materializzarsi: oggi è considerato «razzista» perorare la causa di chi non considera prima e anzitutto la razza, con un ribaltamento completo rispetto all’epoca in cui il primato dell’appartenenza si traduceva in segregazionismo e razzismo.
E se da una parte – come peraltro ricordato dallo stesso Hughes – questa prospettiva è nata per risolvere, a volte con risultati promettenti, problemi veri e attuali (si pensi al diritto allo studio negato a tante comunità afroamericane e all’affirmative action che vuole migliorarne l’accesso all’istruzione superiore), dall’altra non sarà il mito della differenza a ogni costo a salvare il mondo: non solo la color blindness dei bolsi liberal pre-identitari convince ancora la larga maggioranza degli americani, ma il focus sulla tribalità identitaria, peggiorato dalle piattaforme, ha prodotto un già misurabile peggioramento delle relazioni fra bianchi e neri d’America.
Eppure Chris Anderson si è piegato a un gruppo di persone la cui idea è che ci siano idee che fanno del male perché sono diverse dalle loro, e che come tali non meritano di essere diffuse; eppure il testo del discorso sul palco di Hughes, dopo mesi di fact-checking incrociati, è diventato una fonte di grattacapi da cui Ted ha provato a dissociarsi sbarazzandosene; eppure lo stesso Chris Anderson, se il racconto di Hughes è onesto, ci ha mostrato l’ennesimo esempio di cosa succede quando un ente che si relaziona al pubblico e alle masse social diventa ostaggio di ricatti etici, che chiamano risposte marziali per il solo ricorso a un formulario pseudo-attivistico.
E beninteso, oltreoceano succede anche altrove: in California dichiarare che sei per «trattare tutti allo stesso modo» in un test Diversity & Inclusion costa la selezione per il lavoro universitario, ad esempio. Ma dire che dovremmo almeno tendere a trattare tutti allo stesso modo, e poterci approcciare agli altri vedendoli come nostri simili in cui rivedere parti di noi stessi, non è affatto inconsapevolmente razzista: a dire il vero, è la dimensione filosofica del progressismo da un paio di millenni.
Altre news dal fronte
- Siccome non ci sono altre urgenze, è probabile che i pronomi inclusivi finiranno di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti;

- Michael Benz, amicone di Donald Trump ed Elon Musk, a tempo perso è anche un influencer neonazista;

- Idee di pulpito socialmediale per il prossimo Halloween.