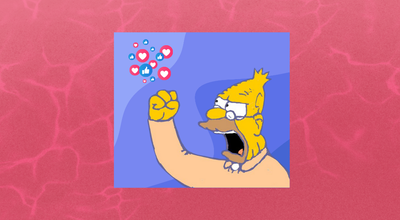Ieri pomeriggio in metropolitana a Milano mi sono imbattuto in un foglio scritto a mano. Era appeso a un distributore automatico con qualche pezzetto di nastro adesivo e diceva semplicemente: «75 coltellate non sono inesperienza».
Il riferimento, come sa chiunque non sia appena tornato da Marte, è alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza che lo scorso dicembre ha condannato Filippo Turetta all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, e che ha suscitato un’ondata di indignazione trasversale per l’assenza dell’aggravante della crudeltà.
Il palcoscenico principale di questo moto di rabbia, nemmeno a dirlo, sono i social media. Il tema è delicato come probabilmente nessun altro, ed è facile urtare la sensibilità di chi è scosso da un dolore che, in ultima analisi, mi sembra avere a che fare con l’esperienza di essere donna nella società odierna – e come tale va non solo rispettato, ma rappresentato e sostenuto. A maggior ragione, che Elena Cecchettin, la sorella minore di Giulia, abbia parlato di una «sentenza pericolosa» non dovrebbe essere materia di discussione.
Ma proprio per questo – proprio perché quel che è successo è successo, e anzi continua a succedere – vale la pena fermarsi, respirare, e provare a capire perché ci indigniamo, come ci indigniamo, e a cosa porta quell’indignazione.
Torniamo agli atti processuali. Per il femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo, senza attenuanti generiche e con il riconoscimento della premeditazione del barbaro assassinio. Nella motivazione si parla di «efferatezza dell’azione», «risolutezza del gesto», «motivi vili e spregevoli». Il motivo per cui non sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà riguarda un’interpretazione tecnica, come spiega bene in un post su Facebook il giornalista di Radio 3 Graziano Graziani: il tribunale ha distinto tra un atto sadico e uno «goffamente eseguito» ma orribile e letale, e ha scelto – in base al codice – di non applicare quella specifica aggravante (ma altre sì, appunto).
Si può essere d’accordo o meno con la sentenza. Ma a rimanere inamovibile è che all’assassino è stato comminato il massimo della pena. Eppure a fare notizia non è stata la condanna all’ergastolo; lo è stato il dettaglio tecnico, opportunamente estrapolato dal contesto dell’iter processuale, delle carte, delle perizie e dell’autopsia, con titoli di giornale che suonavano così:
“Per la Corte, 75 coltellate non sono crudeltà” (La Stampa)
“Assassino ma non crudele” (Open)
È un gioco che nel breve termine fa vendere qualche copia o racimolare qualche click in più, ma nel medio periodo rende tutti più sciocchi e anestetizzati di fronte alle ingiustizie.
In quest’epoca di continue, disperate chiamate di applausi ad personam, non contano le parole giuste: contano le parole che fanno rumore. Questa però, di per sé, non è una buona ragione per estendere la grammatica della decontestualizzazione a ogni ambito.
Il diritto penale, come ha ricordato Valeria Verdolini su Lucy, serve a stabilire responsabilità, non a fungere da risarcimento emotivo instagrammabile. Eppure chiediamo in coro al tribunale di colmare un vuoto simbolico, non sostanziale: non ci accontentiamo della pena – e d’altronde, quale pena potrà mai essere “giusta” di fronte a un caso del genere? – perché vogliamo l’Esempio esorcizzante.
Questa tensione è comprensibile, per molti versi. Ma ciò a cui porta è tutt’altro che salutare: in queste ore i trending topic si sono riempiti di j’accuse virali, teatrini macabri, cascate di video in cui influencer di ogni ordine e grado mimano il gesto dell’accoltellamento su pupazzi, peluche, sacchetti. Un’estetica di inseguimento del trend social che spaccia per attivismo la più miserabile delle ricerche di engagement (e che, a ben vedere, trova il suo rovescio simmetrico nelle nicchie dei redpillati misogini secondo cui Turetta non esisterebbe tout court).
Si è detto che la grande assente da questa pornografia dello sdegno è la sentenza, quella vera, quella scritta dai giudici della Corte d’Assise, certo. Ma il primo problema è proprio nella natura di quella fiumana impetuosa di content; di ciò che ha portato quella persona in buona fede ad appendere quel foglio nella metropolitana di Milano, convinta di aver fatto giustizia.
Perché la viralizzazione del dolore non è mai neutra. Anzi, produce danni concreti. Primo, riduce la soglia dell’empatia reale: a furia di vedere sceneggiate, perdiamo la capacità di distinguere tra testimonianza e performance. Secondo, rende le battaglie autentiche meno credibili, perché quando la soglia della sensibilità sociale si abbassa oltre un certo limite, la sensibilità crolla. Non ci dovrebbe volere un genio per capirlo, ma in casi come questo la denuncia diventa lugubre parodia: il peluche accoltellato non informa, non educa, non fa avanzare nessun discorso culturale. È solo reaction, per l’appunto.
Chi è impegnato per davvero contro la violenza di genere in momenti così si ritrova a dover spiegare, ancora una volta, la differenza tra una campagna e una pantomima inscenata per raccattare qualche like. E ai suoi detrattori in malafede basta un trend grottesco per delegittimare intere lotte. Se le buone cause diventano dispositivi performativi da meme, chi vi si oppone può deriderle con due storie e uno screenshot (e se hai letto qualcuno che diceva che Trump negli Stati Uniti non ha vinto le elezioni anche per queste dinamiche beh, aveva solo voglia di darsi ragione).
Tutto questo ha un effetto concreto ancor più beffardamente deleterio: l’indignazione pubblica finisce per alimentare, paradossalmente, proprio ciò che vorrebbe combattere. Il governo Meloni lo ha capito fin troppo bene, e ha proposto un ddl che introduce in automatico l’ergastolo per i femminicidi, cercando di andare a traino dello spirito del tempo: pene esemplari, simboliche, mediatiche, di scarsi benefici reali.
Nel magico mondo dei social, la giustizia da sola non basta: deve anche sembrare giusta. E in questa richiesta di giustizia-percezione si insinua una forma mentis populista dai mille risvolti – sociale, politico, penale – che propone risposte facili a problemi strutturali, riducendo il progresso a una funzione dell’indignazione rituale e a comando.
Se l’indignazione diventa una coreografia temporanea, da dismettere nel momento esatto in cui il trend passa – la storia prima il video sul femminicidio col pupazzo, quello dopo il nuovo episodio del podcast – la lotta femminista alla violenza sulle donne viene fagocitata dalle miserie della logica dei contenuti. E perdiamo un po’ tutti, chi più e chi meno.
Altre news dal fronte
- Negli Stati Uniti di Trump, uno stylist venezuelano gay può finire in una terribile prigione centramericana dedita alla tortura per errore;

- Ma parliamo un attimo di dazi: sapevi che il buon Trump, un benefattore, li ha messi (e poi tolti) per aiutare gli uomini a superare i loro problemi di virilità?

- Se pensi che della miniserie Adolescence si sia parlato fin troppo, aspetta di sapere quanto ne hanno parlato in Gran Bretagna.