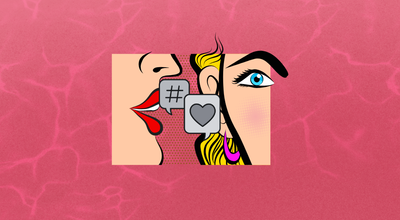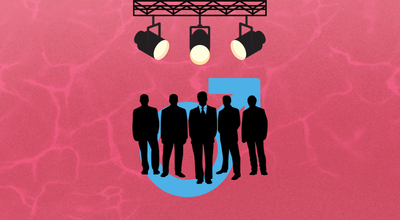La settimana scorsa ho scritto un articolo per Lucy – Sulla cultura, una rivista che si occupa di cultura e attualità. Nell’articolo, che gli editor hanno intitolato «Diagnosticarsi un disturbo mentale per un follower in più», mi interrogo sul ruolo che hanno le diagnosi nel definire la propria identità, offrendo una critica a questa tendenza, e su come i social possano essere causa dei sintomi di disagio mentale che pretendono di affrontare.
Il mio punto era (ed è) che l’essere umano assomiglia molto di più all’acqua che alla pietra, e che le diagnosi, sensibili al momento storico e al contesto in cui ci trova, rischiano di essere un concetto su cui basare la propria identità piuttosto labile e limitante.
Nell’articolo ho anche osservato come proprio sui social negli ultimi anni si sia diffusa una visione del mondo basata su quella che alcuni chiamano social justice culture, identity politics, o, più dispregiativamente, wokeness. L’idea alla base di questa ideologia è che le persone siano categorizzabili in una serie di caratteristiche identitarie, a cui corrispondono vari livelli di oppressione o privilegio, e che la propria identità marginalizzata (di genere, etnica o razziale, basata sull’orientamento sessuale) garantisca autorità sui temi che la riguardano. Molti dei discorsi sulla salute mentale provengono proprio da questa fazione, che ha fatto ad esempio della «neurodivergenza» l’ennesimo marker identitario.
L’articolo ha scatenato reazioni contrastanti. Da un lato ho ricevuto molto supporto, non solo da psicologi e psichiatri, ma anche da persone con disturbi mentali diagnosticati, che non si rivedono in un certo tipo di attivismo che porta inevitabilmente a indentificarsi col proprio disturbo, trasformandolo in una cosa pop e stravagante. Dall’altro, sotto il post Instagram dell’articolo non si contano i commenti ostili.
Un tempo forse si sarebbe detto qualcosa di simile a “non sono d’accordo con questo contenuto” e si sarebbe proceduto ad argomentare smontandolo pezzo per pezzo. La reazione che ha causato questo articolo invece descrive perfettamente, io credo, il tipo di cultura iper-progressista che critico: richieste di rimuovere l’articolo taggando gli editor (probabilmente ignorando che lo abbiamo modificato e approvato insieme, com’è ovvio) e indignazione – tanta da definirlo «scandaloso», «vergognoso», «problematico», «offensivo», e addirittura «violento» – sono in linea con le distorsioni mentali operate da una fazione che ricorre al pensiero in bianco e nero e a un certo catastrofismo («è una microaggressione, non un articolo», «neanche tanto micro!»; «queste posizioni sono dannose!»).
Una neuropsicologa ha minacciato di segnalarmi all’Ordine degli psicologi (a cui non sono iscritto, non essendo né psicologo né residente in Italia), sulla base di presunte inesattezze che avrei scritto, senza mai entrare nel merito delle mie argomentazioni. Per non parlare poi del classico «ascoltate le persone marginalizzate!». Ma chi sono le «persone marginalizzate», qui, esattamente? Poche cose sono sminuenti nei confronti di una categoria quanto l’idea che milioni di persone che ne fanno parte pensino la stessa cosa e aderiscano invariabilmente alla medesima prospettiva.
Ciò che ha turbato diversi lettori è stato il mio aver citato l'autismo e le contraddizioni del concetto di neurodivergenza. Nonostante non fosse il focus dell'articolo, vale comunque la pena parlarne. Di recente mi è capitato di leggere un lungo articolo scritto da Jill Escher, madre di due bambini autistici e presidente del National Council on Severe Autism americano, che, tra le varie cose, descrive i danni concreti del nuovo attivismo per la neurodivergenza. I figli di Escher rientrano nei casi gravi di autismo: non verbali dalla nascita, non in grado di lavarsi i denti o svolgere altre attività quotidiane, incapaci di comprendere concetti astratti quali «compleanno» o «famiglia».
L’attivismo neurodivergente considera il termine «autismo grave» obsoleto e stigmatizzante, ma in che altro modo si può definire una condizione simile? Come mi chiedo nell’articolo, cos’hanno in comune i figli di Escher e tante delle persone che su internet si identificano come neurodivergenti? A chi giova questo tipo di attivismo? Di certo non a tante persone autistiche che non sono in grado di esprimersi tramite tweet e infografiche. Come spiega Escher, se si considera l’autismo una variante del comportamento da celebrare, piuttosto che un’emergenza sanitaria, ne consegue che la ricerca per prevenirlo, trovarne le cause e trattarlo viene ostacolata.
Nel pezzo ho citato anche Clementine, un’amica che fa la scrittrice e che scrive spesso di alcolismo, relazioni e traumi. Trattando temi controversi quali la cosiddetta cancel culture, Clementine non è nuova al dover gestire persone indignate che capiscono poco delle sue intenzioni. Quando le ho chiesto come si comporta quando le persone travisano le sue idee, spesso in cattiva fede, mi ha risposto dicendo che quando scriviamo di temi controversi finiamo nei guai non solo per ciò che abbiamo scritto, ma anche per ciò che non abbiamo scritto né pensiamo.
In molti hanno pensato che io abbia sostenuto che non si dovrebbe parlare di disagi mentali, di dover vergognarsi di soffrirne, o che addirittura pensi che le persone si rivolgono a psichiatri o psicologi apposta per scrivere di avere un disturbo mentale nella bio di Instagram. Inutile dire che sono tutte cose che non penso neanche lontanamente. Per prendere in prestito le parole di Clementine:
Le critiche richiedono che si dimostri comprensione degli argomenti che si intende criticare; molti pensano di stare portando una critica, quando in realtà stanno argomentando contro cose che la persona criticata non ha mai detto.
In questi giorni ho anche ironizzato molto sull’essere stato cancellato dalla comunità neurodivergente e dagli influencer della mental health. Non si tratta di una cancellazione vera e propria, però: la maggior parte dei commenti riguardava l’articolo e non la mia persona, e in ogni caso non posso venire ostracizzato da una comunità di cui non faccio parte. È interessante però soffermarsi sulle modalità di pensiero che sono alla base della cancel culture e di come queste si manifestino. Natalie Wynn (in arte ContraPoints), celebre youtuber progressista e transgender, dopo essere stata cancellata più volte dai suoi fan, ha creato un video di oltre un’ora in cui elenca i trope della cancel culture, un insieme di fallacie logiche e scorciatoie del pensiero che ne stanno alla base e che la alimentano: la presunzione di colpevolezza (spesso un’accusa è abbastanza perché qualcuno venga considerato colpevole, senza alcuna sfumatura); l’astrazione e l’essenzialismo (quando le critiche di un comportamento negativo o male interpretato diventano totalizzanti rispetto all’identità di una persona); lo pseudo-intellettualismo e la tendenza a segnalare la propria superiorità morale per giustificare la deumanizzazione altrui; l’imperdonabilità senza attenuanti (nessuna scusa è mai abbastanza); la colpa per associazione e il dualismo (o “con noi” o “contro di noi”).
Nel mio caso, un esempio di astrazione è l’accusa secondo cui avrei scritto che è sbagliato fare divulgazione su questi temi – che è una cosa che non penso, nel caso fosse necessario ripeterlo. Con l’essenzialismo invece nelle critiche si passa a: questo articolo è abilista, nonostante l’intento nello scriverlo fosse quello di sottolineare come banalizzare o eliminare le contraddizioni che caratterizzano i disturbi mentali implichi fare un grande disservizio a chi ne soffre.
Resta aperta la domanda che fa da sottotitolo al mio articolo: com’è successo che la diagnosi psichiatrica da etichetta delicata sia passata a essere un accessorio da indossare? Ne parlavo qualche giorno fa con un mio professore, che sosteneva come questo rifugio nel Sé, nella propria identità marginalizzata di minoranza da proteggere, sia l’esito di un senso generale di impotenza di fronte a un mondo sempre più deregolamentato e su cui sentiamo di non avere potere. È in un certo senso la vittoria di ciò che sosteneva Margaret Thatcher (non proprio una campionessa di progressismo): la società non esiste, esistono solo gli individui.
Aderire a questo tipo di cultura incoraggia le persone a identificarsi come vittime. Molto spesso in questa prassi non c’è malizia, anzi: può trattarsi di un bisogno umano di riconoscimento e accettazione (faccio spesso ironia sul fatto che a Milano nel cosiddetto terziario avanzato in molti fanno finta di avere tanti soldi, mentre a Montréal, in Canada, dove vivo attualmente, è più comune averli realmente ma spacciarsi per poveri). Non è neanche un caso che in Nordamerica si contano diversi casi di persone che si fingono nere o indigene, e quindi di appartenere a un’etnia diversa dalla propria di origine (solitamente la bianca caucasica), per accedere a riconoscimenti e posizioni privilegiate, ad esempio in ambito accademico.
In passato accadeva il contrario: si millantava un’appartenenza a una classe aristocratica, o negli Stati Uniti i figli white-passing di famiglie nere potevano emanciparsi più facilmente dalla propria famiglia d’origine. Quando vengono scoperte, oggi queste persone finiscono per essere ampiamente criticate e ostracizzate, ma c’è da chiedersi come siamo arrivati a questo punto.
Si potrebbe forse inquadrare come una sorta di rivincita morale degli oppressi, una mentalità per cui denunciare discriminazioni garantisce autorità in virtù di una posizione considerata prossima (per motivi esperienziali o identitari) al peso della marginalizzazione. Ma se per passare da violenti oppressori a vittime basta un ritocco cosmetico, allora qualcosa in questo sistema non funziona. Una persona che ha commentato il mio articolo ha scritto:
Vivo negli USA e qui autodiagnosticarsi l’autismo e l’ADHD è diventata prassi comune. A me non è che dia fastidio [...] Ma queste persone hanno invaso ormai tutti gli spazi dedicati alle persone autistiche, spesso spingendo fuori chi è diagnosticato [...] Appena nomini una diagnosi formale ti attaccano con “è un privilegio” [...] eppure loro non si fanno problemi ad appropriarsi di una disabilità trattandola come un’identità, cosa che io trovo mille volte più abilista.
A fronte di una società che maltratta al di là di ogni dubbio determinate categorie, in contesti progressisti «essere vittime dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto, autostima. Immunizza da ogni critica, garantisce innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio», per fare eco al saggio Critica della vittima. Un esperimento con l’etica di Daniele Giglioli.
Ma questo atteggiamento di riverenza, di cui ha scritto anche il filosofo Olúfẹ́mi Táíwò, dà potere solo in apparenza. In verità, risulta sminuente e non fa altro che tenere le persone in una posizione subalterna.
Aggrapparsi con meno tenacia e monodimensionalità a uno specifico aspetto della propria identità non significa rigettare ogni etichetta per autodefinirsi, o dover negare ogni appartenenza di gruppo, ma aprirsi alla possibilità di emanciparsi e fare passi avanti: perché ci sono cose più complesse e cruciali di un cumulo di like provenienti dalla propria nicchia di convertiti.
Altre news dal fronte
- Twitter, anzi scusa “X” (quanto è matto l’Elon, quanto), è un posto meraviglioso in cui migliaia di persone che si considerano buone, di sinistra e orientate alle migliori cause possono invitare allegramente un tizio che detestano a togliersi la vita;

- Contrordine: le guerre culturali non sono soltanto una distrazione con cui prendersi a ceffoni digitali sui social media;

- Ma tornando brevemente alla salute mentale: perché non rendere il proprio antidepressivo di riferimento una simpatica réclame di Barbie?

(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)