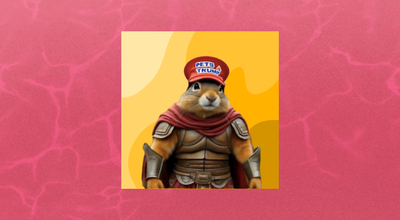Tornare da un viaggio all’estero con poco tempo speso online ha lati impagabili: non sai cosa siano gli «audio di Berlusconi»; ti sei perso ogni prezioso commento sull’ultima polemica orbitante attorno ai Ferragnez; addirittura non ricordi qual era il film preferito da bambina di Giorgia Meloni, sicuro oggetto di un encomiabile articolo del Corriere della Sera.
Un fatterello, però, non poteva che lasciarmi a bocca aperta anche dall’altra parte dell’Atlantico, facendosi largo nel chiasso colorato delle avenue newyorkesi: il presidente del Senato Ignazio La Russa che, rispondendo alla polemica sulla presenza dell’effigie di Benito Mussolini in un luogo istituzionale – la sede del ministero dello Sviluppo economico, Palazzo Piacentini, in occasione dei suoi 90 anni – dice:
[La foto del Duce] c’è anche al ministero della Difesa, e c’è scritto [il suo nome] anche al Foro italico: che facciamo, cancel culture anche noi?
Oh, boy. È successo, insomma: cancel culture non significa più niente, è la battuta-tormentone di Zelig, l’aglio nella cucina del commento politico, la notte in cui tutte le vacche sono nere. Tanto che la seconda carica dello Stato – incredibili, le cose che riuscite a combinare mentre uno è in vacanza – dice «fare cancel culture» come fosse una specie di gergo giovanilistico di cui dimostrarsi impratichiti. Fatta la cancel culture, d’altronde, perché non fare anche l’Harlem Shake?
Più seriamente, è difficile anche cominciare a spiegare perché le discussioni sull’opportunità di rimuovere l’immagine del Duce (leggasi bene: il Duce) da uno spazio pubblico e istituzionale non sono – sospiro – «cancel culture». La Russa, d’altronde, lo sa benissimo da solo: perché Mussolini è stato un dittatore a capo di un regime criminale di cui la nostra Repubblica è la dichiarata antitesi; perché ha perfettamente senso che il suo nome e il suo volto siano oggetto di damnatio memoriae; perché, banalmente, dargli spazio nelle celebrazioni è contrario ai valori sociali fondanti che ci siamo dati settantacinque anni fa.
Non tutto ciò che implica una messa in discussione di una parte di storia è «cancel culture»: la Repubblica italiana, che io sappia, è fondata sul lavoro, non sulla «cancel culture». E applicare indiscriminatamente quest’etichetta non fa altro che svilire e piegare un discorso complesso, oltre a renderlo il terreno di coltura d’elezione dei reazionari che brandiscono il feticcio dello spauracchio del fanatismo progressista.
“Ed è cancel culture, sioresiori” pic.twitter.com/W88NMvYY9X
— Davide Piacenza (@Davide) September 30, 2022
L’uso che la destra fa del termine – anche in casi meno grotteschi di questo, peraltro – mi persuade ulteriormente a continuare a non utilizzarlo, oltre che a pentirmi di averlo fatto in passato: «cancel culture» è principalmente un fischietto per cani che ognuno usa come clava con cui percuotere gli avversari, e come tale ampiamente deprivato della capacità di descrivere la realtà.
Certo, una parte dei fenomeni spesso ricompresi nell’espressione – quelli su cui i La Russa di ogni latitudine non se la sentono di pontificare – rimangono temi che dovrebbero andare oltre lo scornarsi sul termine: come chiamiamo quando una persona comune della working class perde il lavoro perché è stata postata su Twitter da un ossessionato? Come definiamo un tizio a caso che si trova la vita rovinata dagli algoritmi di Tiktok che l’hanno elevato a paradigma di mascolinità tossica? Che etichetta mettiamo sulla riscontrabile tendenza social-indotta a elidere le sfumature e i discorsi complessi, come se tutto fosse (e, peggio, dovesse essere) bianco o nero, progressista o reazionario, accettabile o non accettabile?
Tutto questo, ovviamente, con Mussolini “cancellato” non c’entra nulla, per l’appunto. In Italia il «fanatismo progressista», se esiste, è ben lontano da avere un peso specifico superiore a quello di una piuma al vento.
Il discorso, semmai – sospiro ancora – è culturale. Riguarda la formazione di giovani e giovanissimi, le nuove formae mentis e le modificazioni della nostra psiche sociale, il modo in cui ci rapportiamo agli altri e pensiamo ai rapporti di potere e alle minoranze. Dopo due anni a occuparmi di questi argomenti in modo più approfondito, sono sempre più convinto che dobbiamo trovare il modo di parlarne in modo sensato, aperto e consapevole. E questo modo passa necessariamente attraverso il pensionamento di cancel culture: tolte le parole d’ordine e le caricature che fanno la fortuna di Twitter, chissà che si riesca finalmente a parlare di ciò che succede nel mondo vero e proprio.
Altre news dal fronte
- Spiace per l’olimpionico del salto in alto Gianmarco Tamberi, ma la sua solidarietà a Paola Egonu e Zaynab Dosso, atlete vittime di razzismo, espressa alla Gazzetta dello Sport è qualcosa di più che imbarazzante: «Tra basket e musica io sono nero dentro, tutti i miei idoli sono persone di colore»? Seriously?

La copertina dell’#Economist è vergognosa ed offensiva nei confronti dell’Italia. Giornalismo di qualità? pic.twitter.com/tP6CaGYzv3
— Marcello Foa (@MarcelloFoa) October 20, 2022
- Perché questa copertina dell’Economist ha fatto scattare moltissimi sull’attenti (compreso l’ambasciatore italiano nel Regno Unito, che si è sentito in dovere di puntualizzare che non siamo solo pasta e pizza)? È una domanda più interessante delle motivazioni dietro alla pigra rappresentazione del settimanale, e che potrebbe riservarci sorprese: perché un senso anche lasco di unità nazionale in Italia esiste solo in corrispondenza di un’offesa percepita?

- La maggior parte degli editor della rivista letteraria Hobart si è licenziata dopo un’intervista allo scrittore cubano-americano Alex Perez, pubblicata sul sito di Hobart: è molto lunga e io ho troppo jet lag addosso per leggerla tutta, ma a una prima occhiata non ci ho trovato i motivi di scandalo che LitHub (primo link) dice di vederci. La leggerò meglio, ma di sicuro pare un contenuto interessante.