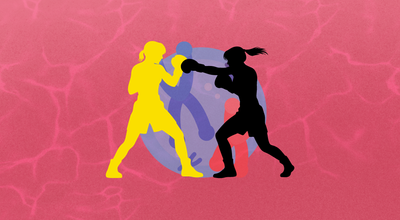Buongiornissimo, sono Davide Piacenza e questa è la mia newsletter, Culture Wars, che tratta di politicamente corretto e di Checco Zalone (no, ovviamente scherzo, ma Sanremo è Sanremo, per cui ci toccherà parlare anche di quella cosa là).
Però prima: Joe Rogan e Spotify.
Cancellare Average Joe
Avrete sicuramente un’amica o un amico che ha un podcast. Ecco, Joe Rogan ha un podcast che gli è fruttato più di 100 milioni di dollari quando nel 2019 ne ha venduto i diritti a Spotify, ed è anche quello col pubblico più ampio del mondo: 11 milioni di ascoltatori ogni episodio. Joe Rogan è una sorta di Giuseppe Cruciani d’America, e il suo show una sorta di Zanzara: incarna i punti di vista del cosiddetto “uomo comune”, strizzando l’occhio ai bassi istinti.
Why is Joe Rogan so popular --- and so controversial? Because he's talking to people in a way no one else is. A classic by @DevinGordonX https://t.co/owyezZFquk pic.twitter.com/1k2126xWg1
— nxthompson (@nxthompson) February 2, 2022
Nelle ultime settimane The Joe Rogan Experience è finito al centro di un caso politico che riassume la quintessenza delle culture wars: cosa succede quando il podcast più ascoltato di sempre spaccia balle colossali sul Covid-19 e i vaccini (Rogan l’ha fatto ospitando in un episodio Robert Malone, noto e controverso virologo antivaccinista)? Beh, succede anzitutto che i medici e gli scienziati veri e propri si incazzano, comprensibilmente.
E poi succede qualcos’altro: vecchie icone del rock come Neil Young e Joni Mitchell decidono di ritirare la loro musica da Spotify, una forma di protesta verso la piattaforma che decide de facto di diffondere fake news con ricadute pericolose, poi seguite da altri cantanti. Quindi, inevitabilmente, la questione finisce sui social, dove prende piede l’hashtag #DeleteSpotify, che si intensifica quando il Ceo di Spotify Daniel Ek annuncia una revisione delle policy sulla disinformazione dei contenuti, ma non si sogna nemmeno di privarsi di Rogan (il quale annuncia a sua volta vaghe promesse di migliorare).
Il problema, come ha detto la giornalista Kara Swisher, è che se – citandolo – Ek «non vuole essere un “censuratore di contenuti”, allora non dovrebbe comprare contenuti». È un discorso che abbiamo sentito tante volte in bocca a Mark Zuckerberg di fronte alle critiche ricevute da Facebook: è solo una piattaforma, non sta a noi fare da arbitri della verità. E invece no: Facebook e Spotify nel 2022 sono media company fatte e finite, che con una scelta (e con acquisizioni miliardarie) plasmano l’opinione pubblica e l’accesso alle informazioni.
Ecco perché le alte grida di “cancel culture” che si sono levate in difesa di Joe Rogan mi sembrano male indirizzate, quantomeno: Spotify è un’azienda, non una persona, e la scelta – o la pressione – di cancellare un servizio si chiama boicottaggio, non cancel culture. Disinstallare Spotify è una scelta (o una campagna) di consumo consapevole, non un attentato alla libertà di espressione. Confondere i piani fra le due cose, a mio modo di vedere, è il peggior modo di comprenderle. Cito ancora Swisher sul New York magazine:
Questi artisti possono fare il diamine che gli pare. Se non gli piace Spotify, non sono tenuti a esserci. Si chiama protestare, non cancel culture. Sono sicura che i guerrieri della cancel culture stanno già lamentandosi dicendo che è cancel culture. No, non lo è. Non c‘è problema se non vuoi mangiare da Chick-fil-A o non bevevi il succo d’arancia Florida quando Anita Bryant era la sua portavoce. Succede da sempre. Benvenuti nella lunga tradizione delle persone che protestano contro le aziende.
#CultureWarsMeets: Stefano Andreoli ⬇

Grande è la confusione sotto il cielo: nella serata di mercoledì Checco Zalone, il comico nazionalpopolare per antonomasia, ha portato sul palco del Festival di Sanremo tre sketch. In uno di essi, Zalone interpretava una donna trans brasiliana invitata a un ballo di corte in Calabria e insomma, forse l'avete vista: nonostante il registro e la rappresentazione satirica di un personaggio ignorante e omofobo – il padre della protagonista, che ne usciva come il fesso della situazione – da più parti sono arrivate accuse di perpetuazione di stereotipi oppressivi, e alcuni hanno accusato il comico di transfobia.
Considerato il target e il contesto (non esattamente una retrospettiva femminista su bell hooks ospitata da un centro sociale autogestito), non sono molto d’accordo con le critiche. Ma anche chissenefrega di cosa ne penso io, specie quando possiamo parlarne con Stefano Andreoli, autore televisivo, radiofonico, di importanti comici del panorama nazionale (facciamo nomi? Facciamoli: Bisio, Crozza, Luca e Paolo, il mago Forest, Gialappa's Band, Savino, Lundini) e anche di un’edizione di Sanremo, quella del 2012. Questa è #CultureWarsMeets.
⪢ Da autore puoi dircelo, anche se spiegare una battuta è la colpa più turpe di cui ci si può macchiare: nello sketch-favola in cui impersonava la transessuale calabrese vittima del padre omofobo, qual era il bersaglio di Zalone? Secondo te l’ha centrato?
Concordo con la premessa, e quindi non azzardo sentenze né giudizi. Capisco le ragioni di chi ha criticato il pezzo, ma penso anche che chi lo difende abbia tutte le ragioni per farlo, specie visti i toni fuori misura che si sono sprigionati dopo l’esibizione. L’abilità di Zalone è sempre stata quella di saper colpire una pluralità di bersagli, un campionario di tipi umani che popolano il quotidiano, restando sempre su quel sottilissimo filo teso tra la satira e lo sfottò, tra la critica e l’indulgenza, tra il dissociarsi da un comportamento e il compiacersene.
Pensare di tracciare una linea di confine, un limite oltre il quale non ci si può spingere in nome del buon gusto, o una presunta sensibilità comune, è una trappola senza uscita: e vedo tanti, anche addetti ai lavori, cascarci dentro.
Un presunto umorismo “edificante” che metta d’accordo tutti, spari sempre e solo verso l’alto rispettando ogni minoranza, e faccia ridere senza offendere nessuno, credo possa funzionare solo in teoria, ma in pratica sarebbe noioso e irricevibile.
⪢ Da più parti, durante e dopo l’esibizione, si sono levate voci di critica, anche decisamente aspra: l’influencer e autrice Carlotta Vagnoli ha commentato Zalone con volto sgomento, definendo il tutto «inaccettabile»; un altro post Instagram con 25mila like ha definito il contenuto dello sketch «transfobico». Tu come la vedi?
Ci sono trecento punti di vista possibili su questa faccenda, e penso che una sintesi sia impossibile. Da una parte è indubbio che la sensibilità, in media, stia evolvendo e che un artista non possa non tenerne conto – scegliendo, eventualmente, di andare controcorrente – ma, d’altra parte: è davvero così produttivo pretendere di elevare la propria sensibilità a metro di giudizio universale? Vedo un’ansia di indignazione, un clima saturo in cui ci si scanna per una battuta, senza ammettere sfumature, senza desiderio di dialogare. Qualcuno ride, e noi pretendiamo di spiegargli perché non deve ridere. Dimenticando che il comico deve avere licenza di calpestare qualsiasi tabù, distorcere, deformare, impersonare maschere sgradevoli; sarà il pubblico nella sua totalità a giudicarlo, non un autoproclamato consesso dei Giusti. A volte pensiamo di rappresentare l’universo intero, poi ci allontaniamo un po’ e scopriamo che ci stiamo azzuffando sotto la lente di un microscopio, e il mondo continua a girare. Perché, alla fine, stiamo solo parlando di parole: sono solo battute, e le stiamo trattando al pari di abusi concreti, di violenza vera. Per quanto possano suonare sgradevoli, sarebbe forse il caso di ridimensionarne il valore, insegnare e imparare a non dare loro peso: e invece siamo arrivati alla glorificazione dell’offeso, come se fosse un caduto in battaglia.
⪢ In un commento su Facebook sulla vicenda hai scritto che «ognuno di noi oggi vive in un mondo del quale è il centro di gravità assoluto e permanente, metro singolo di giudizio, giustiziere degli oppressi, rivendicatore di buone cause anche per conto terzi», e mi sembra un buon angolo da cui affrontare la questione: ci dici di più?
Penso che l’attivismo, in genere, si divida in due grandi sottoinsiemi: chi costruisce ponti, e chi pianta bandiere. Un ponte serve ad arrivare dove prima non potevi arrivare, e costruirne è molto faticoso: si fa attraverso le leggi, attraverso la giustizia, attraverso l’educazione. Si fa rimuovendo concretamente le barriere, fisiche, legali e culturali. Ho molta stima di chi, oggi, costruisce ponti; e non sono in molti a farlo. Anche piantare bandiere può essere utile, certo, ma è un po’ meno faticoso. Soprattutto se per piantarla non devi spostarti di un millimetro dal punto in cui ti trovi. Ho l’impressione che oggi ognuno di noi abbia una bandiera in mano e stia aspettando solo il momento giusto per sventolarla, la luce giusta per esprimere la propria presa di posizione a favore di telecamera. In molte battaglie di bandiera, anche le più nobili, c’è una componente di vanità: questo hashtag l’ho lanciato io, questa iniziativa ha copiato la mia, eccetera. Una volta si saliva sul carro dei vincitori, ma oggi anche salire sul carro degli offesi può rivelarsi un buon affare.
Altre news dal fronte
- Whoopi Goldberg, tra le altre cose l’indimenticata Deloris di Sister Act, è finita nell’occhio del ciclone per alcuni commenti fatti in diretta durante il talk di Abc News The View: parlando della Shoah, Goldberg ha detto che «non è stata questione di razza», dato che a suo dire si è trattato di una cosa fra «due gruppi di persone bianche». Poi si è scusata su Twitter, ma il network l’ha sospesa per due settimane;

- Il docente di orientamento libertario della Georgetown University Ilya Shapiro ha condiviso una serie di tweet controversi sulla prossima nomina di Joe Biden alla Corte Suprema americana: secondo Shapiro, la scelta più giusta e meritevole per prendere il posto lasciato vacante dal giudice Stephen Breyer sarebbe stato l’indiano-americano Sri Srinivasan e Biden, scegliendo una donna nera, opterà per una scelta «inferiore» (cioè: di minore qualità) per adeguarsi ai dettami dell’identity politics. L’università l’ha sospeso;

- Sintesi dei due casi precedenti, che negli Stati Uniti hanno tenuto banco per tutta la settimana: questo tweet, che ti prego di stampare e appendere in cameretta. Ci servirà.
Here's my radical hot take: Forgive Whoopi Goldberg, forgive Ilya Shapiro, forgive everyone who says something dumb & then apologizes. No one is the sum total of one stupid comment, & I don't want to live in a world where saying "I'm sorry" carries no currency.
— Billy Binion (@billybinion) February 2, 2022