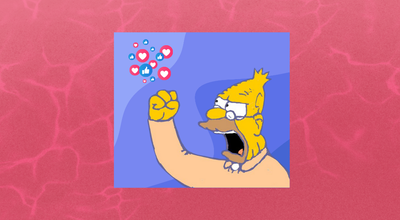Le immagini si susseguono molto velocemente, così come le parole, incomprensibili, e i prodotti. Lo sfondo è arancione, sembra di essere in un magazzino, con tutti i pacchi impilati in modo ordinato. Un timer, in basso a destra, scorre. Al centro della scena, l’influencer cinese Xiang Xiang e il suo innovativo – dicono – modo di suggerire oggetti da acquistare: due secondi per presentare il prodotto, scandire il prezzo e via al prossimo. Funziona, dicono i media internazionali: Xiang avrebbe guadagnato circa 18 milioni di dollari in una settimana.

Quelle immagini, a loro modo ipnotiche, hanno richiamato alla mia memoria una scena di The End of the Tour, il film che racconta l’intervista di David Lipsky a David Foster Wallace, subito dopo la pubblicazione di Infinite Jest. A un certo punto, i due tornano a casa e iniziano a parlare di solitudine. Jason Segel/Foster Wallace dice:
La tecnologia avanzerà sempre di più e sarà sempre più facile, sempre più comodo, sempre più piacevole starsene seduti da soli a guardare immagini fornite da gente che non ci vuole bene, me vuole i nostri soldi. Questo va bene a piccole dosi, ma se questa è la base della tua alimentazione, muori. In un senso molto profondo, finisci per morire.
Quella di Xiang è, in un certo senso, una rivelazione violenta di una questione ormai evidente nell’analisi sociale del web. Quelle piattaforme nate come spazi di confronto, con mission ambiziose come “connettere le persone”, sono ormai sempre più abitate da un lato da semplici fruitori, e dall’altro da creatori di contenuti di professione.
È un percorso iniziato tempo fa, quando la rottura di un certo velo di ingenuità ha rivelato che sul web e i social media si poteva davvero guadagnare prima di tutto attraverso la “vendita” di se stessi (il famigerato personal branding), e poi attraverso la proposizione di prodotti da acquistare.
Taylor Lorenz, nel suo libro Extremely Online, fa risalire questo processo alle mamme blogger dei primi anni del Duemila, le prime, scrive Lorenz, «a costruire brand personali, a rendersi prodotti (commodifying themselves in inglese rende ancora meglio l’idea)» costruendo comunità online.
Del resto, c’era un vuoto che andava riempito: con la crescita nell’uso degli smartphone, il web era alla ricerca di accentratori, di un nuovo star system di persone e organizzazioni in grado di interpretare quegli spazi, di abitarli secondo le loro regole. Serviva una ri-mediazione: ok, ci sono gli algoritmi delle piattaforme, ma di chi fidarsi all’interno di quell’esplosione di articoli, contenuti, post?
In questo contesto, il valore predominante è stato l’autenticità. Ovvero, questo nuovo star system si presentava come qualcosa di diverso: persone qualunque che, grazie alle possibilità offerte da quella nuova tecnologia, si mettevano al servizio degli utenti, per offrire loro consigli, opinioni, intrattenimento. È un patto tacito da cui inizia una parte consistente di quello che oggi consideriamo il successo online: Salvatore Aranzulla è solo un nerd che risolve problemi tecnologici, Chiara Ferragni una ragazza con la passione per la moda, eccetera.
«C’è questa idea» – dice il giornalista Michael Serazio in un recente articolo su Vox – «che tutto venga fatto per amore e non per soldi, senza secondi fini. Questo ha creato nel pubblico l’aspettativa che queste persone siano affidabili, e questo è esattamente ciò che le rende preziose per poi vendere per conto di operatori di marketing e aziende».
È un paradosso: per funzionare – in un mercato che solo nel nostro Paese vale 400 milioni di euro – bisogna essere autentici. Ma perché valga la pena buttarcisi, in quel mercato, bisogna trovare un modo di guadagnare: e quindi collaborazioni, sponsorizzazioni, pubblicità e altre cose ben poco autentiche.
Così il web diventa un posto che non è più divertente, secondo Kyle Chayka del New Yorker, dominato da «una manciata di giganteschi social network che hanno preso il controllo dello spazio aperto di internet, centralizzando e omogeneizzando le nostre esperienze attraverso i propri sistemi opachi e mutevoli di raccomandazione di contenuti».
Sistemi che solo chi pensa di poter guadagnare, di poter essere in grado di vendere qualcosa, ha interesse a conoscere profondamente, a sfruttare a proprio vantaggio. È un circolo vizioso: l’idea di poter fare soldi online è un motore fortissimo per iniziare a pubblicare, secondo quell’illusione – figlia del nostro rapporto precedente con i social network – per cui in realtà non è un lavoro, ma una passione.
E allora chi comincia lo fa con un obiettivo preciso, un progetto, un punto di approdo. E si informa, sfrutta i sistemi di raccomandazione delle piattaforme, pubblica molti contenuti. E la sensazione è quella di annegare in un mare di influencer, content creator, divulgatori.
Di recente, come chiunque dia anche uno sguardo distratto al mondo di Internet, mi sono imbattuto in alcuni video di Giuliana Florio, la creator che ha portato nel nostro Paese il fenomeno degli Npc. È una ragazza che va in diretta su TikTok e, a partire dagli stimoli del pubblico (like o regali) risponde con gesti predeterminati, come dire una certa cosa o fare un certo gesto. È come premere un tasto, a cui corrisponde una reazione.
Ecco: Florio in alcuni video pubblicati a corredo di questa attività racconta che lei non è solo questo, che dietro le dirette Npc c’è qualcosa di più profondo, che nella vita vorrebbe fare altro. Ma pochi, nei commenti, sembrano darle credito: lei, per il pubblico algoritmico da cui dipendono le sue fortune, è solo un personaggio non giocante.
Dall’altra parte dell’Oceano, Mr. Beast (lo youtuber più famoso al mondo) di recente ha pubblicato l’ennesimo video in cui mostra alle sue centinaia di milioni di follower il suo buon cuore: nel contenuto, racconta di aver costruito 100 pozzi in alcuni Paesi dell’Africa. Ma è stato criticato, come spesso gli capita in situazioni del genere. Sulla sua newsletter Garbage Day, Ryan Broderick se lo spiega in modo piuttosto semplice: Mr. Beast è solo contenuti virali; è chiaro che ogni cosa che fa fuori da quel campo suoni finta, artefatta.
E il punto, infatti, non è tanto la vendita di prodotti in senso stretto. È un ecosistema costruito intorno alla categorizzazione delle identità, poste negli scaffali algoritmici di riferimento. Un bell’articolo su The Outline racconta le difficoltà di crescere un adolescente in un mondo in cui le identità sono ridotte a «tipi», a partire da una teoria secondo cui la definizione di noi stessi non dipende dal comportamento, ma viceversa. Sei prima un tipo, una caratterizzazione precisa: è da lì che decidi come comportarti.
Come sempre, quando si parla di digitale, si può fare riferimento a circostanze meramente tecniche. Quando, in una delle poche cose vagamente intelligenti che ha fatto dopo la presa di Twitter, Elon Musk ha reso pubblico parte dell’algoritmo della piattaforma, è venuto fuori che quella che oggi si chiama X categorizza gli utenti a partire dagli argomenti di cui postano. E che, piuttosto prevedibilmente, se io mi occupo di calcio e pubblico un post sulla musica, quel post viene penalizzato, viene mostrato a un numero inferiore di persone. Perché chi siamo noi per complicare il lavoro dell’algoritmo, chiamato a far incontrare nel modo più efficace possibile domanda e offerta?
È un fatto tecnico, che diventa sociale. Per funzionare, devi stare sullo scaffale, ancora prima di vendere qualcosa. E devi starci in una corsia precisa, ben identificata: riconoscibile, facile da categorizzare prima dell’inevitabile pollice su, prossimo video.
E il dibattito pubblico, prima online e poi offline, diventa nient’altro che riaffermazione di identità, una lotta per occupare o presidiare il proprio scaffale.
Altre news dal fronte
- Parlando di algoritmi e quel che producono: su TikTok è diventata virale, a distanza di vent’anni, la famigerata lettera di Osama bin Laden contro l’America: molti tiktoker con seguiti oceanici l’hanno definita illuminante;

- Salutiamo con favore il licenziamento di Suella Braverman, fino a pochi giorni fa ministra dell’Interno britannico, nonché folle olimpionica di culture wars reazionarie;

- Chiedere ad artisti e scrittori di prendere posizione sulla Palestina (o su qualsiasi altra questione politica) non è quel che pensi.