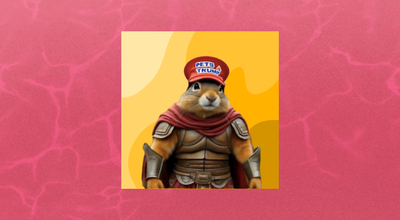Uno spettro si aggira per l’America: è lo spettro delle drag queen. Se mi perdoni l’apocrifo marxiano, la sostanza non cambia: su entrambe le sponde dell’Atlantico i performer drag, da innocui artisti simbolo della cultura gay quali erano fino a ieri, sono finiti al centro del gorgo degli scontri politici e culturali di un’era sempre ansiosa di trovare nuovi casus belli.
Non ti sorprenderà apprenderlo, ma il motivo che li ha elevati a nemico pubblico numero uno ha poco a che vedere con la buona fede. In Tennessee è arrivata la prima legge di uno Stato a guida conservatrice contro le drag queen: l’ha firmata il governatore Bill Lee, e non si rivolge direttamente ai performer, ma da luglio, con una scelta di circonlocuzioni che lasciano poco spazio ai dubbi, proibirà le «performance per adulti dannose nei confronti dei minori» portate in scena da «imitatori di maschi o femmine», accostati indistintamente agli intrattenitori sessuali.
Com’è che le istituzioni del Tennessee sono arrivate a promulgare questa fondamentale, imprescindibile legge? Beh, detta semplice: una propaganda reazionaria martellante da mesi ha messo nel mirino le story hours – un programma nazionale statunitense di incontri nelle scuole o nelle librerie in cui le drag queen leggono libri per bambini – indicandole come esempi di perversione a opera di una sinistra attivamente impegnata a esporre gli infanti a spettacoli di natura sessuale. E la polemica, come spesso accade in questi casi, ha fatto il giro del mondo (quantomeno di quello anglosassone), col britannico Times che ha definito i drag show «l’ultimo fronte delle guerre culturali».
Le obiezioni sono tutte giuste, non fosse che sono tutte sbagliate: in primis perché – udite udite – non c’è niente di «sessuale» nelle story hours. Sono eventi per bambini e come tali, di norma, completamente privi di contenuti inadatti per l’infanzia. Vedere per credere: questa di seguito è una story hour andata in scena a New York. Nota il clima teso ed evidentemente perverso, caro lettore o cara lettrice.
Senza contare che la storia del drag, prima di diventare parte integrante della cultura queer, risale indietro fino alle rappresentazioni delle opere di Shakespeare, quando i ruoli femminili venivano interpretati da attori uomini vestiti con parrucche e abiti lunghi, e passa per la Germania di Weimar, il vaudeville, l’era proibizionista e il secondo dopoguerra, un’epoca tutt’altro che libertina in cui, tuttavia, ad andare in tv vestito da donna era il primo vero volto della tv statunitense, Milton ‘Mr. Television’ Berle.
Insomma: di per sé, nelle performance drag non c’è nulla di scandaloso. Il punto è che negli ultimi anni – e soprattutto negli ultimi mesi, a dire il vero – le drag queen sono diventate loro malgrado il capro espiatorio perfetto della paranoia sistematizzata dai conservatori e (soprattutto) dalla destra estrema, che le ha rese il simbolo dei mali del mondo «inclusivo».

Libs of TikTok, la maggiore cassa di risonanza della propaganda anti-gender di Twitter, non lascia passare un giorno senza postare video di drag show per bambini con vari gradi di sessualizzazioni implicite o esplicite, e l’abitudine si è già tradotta in conseguenze nel mondo reale: a giugno dell’anno scorso un manipolo di estremisti di destra del gruppo dei Proud Boys ha impedito fisicamente lo svolgersi di una story hour in California, e proteste del genere sono arrivate anche nell’altro bastione liberal di New York City, oltre ad aver passato il confine e aver fatto capolino in Canada e in Gran Bretagna.
Non solo gli influencer di destra più e meno estrema, ma nemmeno la stampa mainstream dell’establishment conservatore si perde più un singolo caso di drag show a tutti gli effetti questionabile: qualche deriva c’è (il commosso premio della critica vada alla drag queen a lezione in una scuola dell’Isola di Man che si è messa a litigare con un undicenne sull’identità di genere), e alcune anche piuttosto gravi, ma nulla che suggerisca che i singoli casi inappropriati non siano eccezionali, o – peggio – che iniziative del genere nascondano una volontà di adescamento (grooming, per rimanere alla terminologia delle guerre culturali americane) di minori, come sostiene la claque anti-Lgbt+.
Fai uno sforzo di immaginazione, di quelli che uno preferirebbe non fare: se fossi un performer drag con intenti malevoli nei confronti di bambini in età scolare, cosa faresti per attirarli? Ah, come dici? Inviteresti i loro genitori a portarli in una biblioteca pubblica, dove gli leggerai dei libri illustrati? Ecco, ci siamo capiti: loro saranno pure esageratamente truccati, ma i pagliacci veri sono i loro detrattori.
Posso anche comprendere, in parte, quei genitori che non vogliono esporre i loro figli a iniziative di questo genere. Il fatto è che qui nessuno sta imponendo niente a nessuno, mi pare: se vuoi portare il piccolo John Maria a sentire le storie lette dal signore con la parrucca colorata nella library comunale, bene; altrimenti puoi comodamente tenerlo a casa, in modo che continui a sparare col mitra sui passanti giocando a GTA V. Where is the problem?
Da Bibbiano in avanti, la grancassa della destra di ogni latitudine continua imperterrita a suonare lo stancante motivetto della sinistra che allunga le mani sui bambini. Un motivetto destinato a ulteriore popolarità nell’epoca delle culture wars, purtroppo. Non resta che prenderla con filosofia: come ha detto una volta RuPaul, noto fuorilegge del Tennessee, «la chiave per navigare questa vita è non prenderla troppo seriamente».
Altre news dal fronte
- Siccome qui cerchiamo di accontentare anche i palati più esigenti, ecco una bella disamina di come le dannate culture wars si sono impadronite anche del tira e molla interreligioso che perseguita due tra i monumenti più belli del mondo, la moschea-cattedrale di Cordoba, in Spagna, e la basilica di Santa Sofia a Istanbul;

- La causa di Stephen Elliott, fondatore del sito letterario The Rumpus, nei confronti di Moira Donegan è finita con un risarcimento a favore di Elliott. Donegan nel 2017, in pieno #MeToo, era stata la creatrice della Shitty Media Men List, un documento online che ospitava segnalazioni anonime di molestie e comportamenti inappropriati da parte di uomini dell’editoria americana. Quando il documento è diventato pubblico, Elliott ha definito le accuse «completamente false» e ha denunciato Donegan – la quale oggi è una columnist del Guardian sui temi di cui parliamo da queste parti – per diffamazione; un altro degli uomini finiti nella lista pur essendosi dichiarati innocenti, il freelance Mike Tunison, ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo le accuse;

- Non so se conta come link bellico-culturale, ma in ogni caso chissenefrega: un articolo straordinario del sociologo premio Pulitzer Matthew Desmond sul perché la povertà persiste in America (in buona sostanza, non è tanto questione di un welfare stitico, quanto di meccanismi di sfruttamento dei meno abbienti e di mancanza di diritti sul lavoro).

(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)