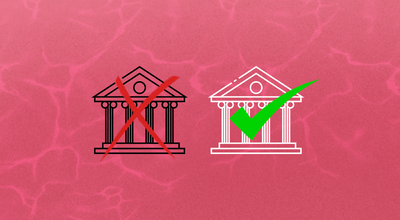Alle 19 ora locale di Gaza City un razzo ha colpito l’ospedale Al-Ahli, gestito dalla Chiesa anglicana, che secondo le stime in quel momento ospitava un migliaio di profughi palestinesi in fuga dall’assedio di Israele. Secondo le fonti palestinesi sono morte 471 persone; secondo quelle israeliane, qualche decina.
La tragedia, come è stata raccontata su buona parte dei media, è servita a rafforzare convinzioni pre-esistenti: i filo-palestinesi si sono detti certi fin da subito che ad armare quell’ordigno è stato l’esercito israeliano, mentre i filo-israeliani non hanno mai avuto dubbi che si sia trattato di un razzo di Hamas finito lì per errore.
Quella dell’ospedale Al-Ahli è solo l’ultima incarnazione di un approccio deteriore al conflitto arabo-israeliano che trova nelle piattaforme digitali il suo migliore alleato e che si sta rivelando l’ennesima, nonché più turpe, occasione per piantare una bandierina – metaforica o in formato emoji – e dichiarare un’appartenenza gregaria nella divisione rituale a squadre. Se la tragedia è polarizzante, delle vittime che ci importa?
Uno dei momenti più drammatici degli ultimi decenni di storia – e uno che verosimilmente avrà un’onda lunga di conseguenze nefaste sulla politica internazionale per anni – si sta dispiegando sotto i nostri occhi, ma noi siamo troppo impegnati a giocare a indiani e cowboy su Twitter/X per discuterlo come meriterebbe. E poi, insomma, delle vittime che ci importa?
Non è questa la sede per provare a trovare i molteplici bandoli delle infinite matasse della guerra in Palestina, e per fortuna – cercando con un po’ di buona volontà – si riesce ancora a trovare chi lo fa da tempo. Ma quel che è certo è che, al di fuori del mondo delle favole e dei like, non esistono un colpevole assoluto e un innocente assoluto; sì, Israele si sta macchiando di azioni terribili nella Striscia; sì, Hamas se ne è macchiata in precedenza. Prima ancora l’aveva fatto Israele. E prima di allora Hamas. E via discorrendo: la lunga scia di orrore e sangue va indietro fino a prima della guerra dei sei giorni e del mandato britannico in Palestina.
Sui nostri profili social e, sempre più spesso, nelle nostri menti invece è tutto bianco o nero: sappiamo benissimo che c’è una parte – incidentalmente, quella che sosteniamo – inossidabilmente vittima e una parte inevitabilmente carnefice, e la nostra assoluta priorità è trovare conferme a questa visione parziale e manichea. Delle vittime, che ci importa?
Per essere del tutto onesto con te, sono da sempre ben più filo-palestinese che filo-israeliano, per ragioni su cui non mi dilungherò, ma in questi giorni nei ranghi della mia presunta fazione di appartenenza ho letto pressoché di tutto fra le uscite capaci di far rizzare i capelli: complotti che coinvolgono bambini israeliani uccisi; sionisti che pagano i partecipanti alle manifestazioni pro-Israele; Hamas come forza della “decolonizzazione”. E le ho lette, queste cose, anche da persone intelligenti e scolarizzate, non da pazzi urlanti.
Poi però, per fortuna, mi sono imbattuto anche in cose ottime. La migliore riguarda quella tendenza insita in ognuno di noi contemporanei ipermediatizzati a farci portavoce istantanei e inflessibili di cause e gruppi terzi: l’ha pubblicata sul suo profilo Facebook la scrittrice Helena Janeczek, e io te la ripropongo così com’è.
In Germania – dove non governa la destra – si raggiunge delle vette di assurdo nel declinare «la storica responsabilità» di difendere lo Stato e il popolo ebraico. Come l'altro giorno a Berlino, dove la polizia ha impedito di manifestare il no all'occupazione e all'assedio di Gaza anche a un gruppo di pacifici (e/o pacifisti) israeliani di sinistra.
Da figlia di sopravvissuti nata e cresciuta nel Paese dei carnefici non accetto questo paternalismo compiaciuto che mi assegna una posizione di vittima eterna, dunque per sempre minore, benché spesso disattento all'antisemitismo presente nella destra – nell’Afd bavarese, per esempio.
Da persona che scrive e riflette, voglio, proprio ora, continuare a poter conoscere i libri, gli articoli e i commenti provenienti dalla Palestina e dal mondo arabo. Perché è così che si coltiva la democrazia in opposizione a tutte le forme di illiberalismo, estremismo e fanatismo.
E perché, egoisticamente, non mi sento affatto più tranquilla se dai contesti che dovrebbero essere i più aperti al confronto, arriva la conferma che certe voci vanno silenziate a vantaggio di altre che si prendono tutto lo spazio. Non ne viene fuori niente di buono.
Non ho altro da aggiungere: si può sostenere una causa senza diventarne ultrà pronti a tapparsi le orecchie (e a tappare la bocca altrui) per timore di perdere la corsa a chi è più partigiano, nel senso peggiore: la vicenda di Adania Shibli, la scrittrice palestinese che non ha potuto ricevere il suo premio alla Fiera del libro di Francoforte «a causa della guerra avviata da Hamas» (ne ho scritto qui, su Esquire) è una vergogna.
Ed è una vergogna anche avere governanti dei Paesi più influenti d’Europa che si comportano come influencer in ansia da prestazione («politici sempre più simili ad influencer, finché non candideranno loro direttamente», scrisse d’altronde il poeta), anteponendosi alle parti in causa in cerca di un’inesistente purezza da sbandierare in post e tweet.
Dobbiamo essere migliori di così. E dobbiamo non su un vago piano retorico, o per lontani imperativi morali: siamo chiamati a farlo da un mondo che è sempre più stratificato, complesso – ben oltre la pantomima russofila della complessità orsiniana – da capire e indirizzare con un approccio critico e riflessivo che ci stiamo perdendo per strada. L’alternativa è subirlo, anche se con una bandierina in bella vista nel nickname.
Una versione alternativa di questo articolo è uscita su Snaporaz.
Altre news dal fronte
- È stato misteriosamente nascosto in un anfratto del sito, ma Fanpage ha pubblicato un estratto dal mio libro La correzione del mondo, titolato: «Per chi parla davvero l’attivismo social?»;

- La storia terribile del 23enne che si è ucciso in diretta su TikTok dopo essere stato diffamato dalla sua comunità online di riferimento: che belli i social media;

- Chi l’avrebbe mai detto che nel 2023 questa breve guida di una rivista, un tempo anche seria, contro lo shadow ban dei contenuti a tema Palestina su Instagram («inserisci qualche selfie tra i post sul genocidio») non sarebbe stata una parodia, ma la realtà in cui viviamo;

- Il dramma delle discriminazioni patite dalle persone aromantiche e poliamorose (questo accostamento al «popolo palestinese» fa spavento, per non dire altro).