Hi there, io sono Davide Piacenza e questa è la mia newsletter, Culture Wars, che tratta di politicamente corretto e della complicatissima coesistenza delle nuove sensibilità sociali nell’anno Domini 2022, evitando accuratamente la reductio ad shitstorm su Twitter.
Pronti, partenza, via.
Tutte le donne di West Elm Caleb
Il caso della settimana – ma più probabilmente del mese – di cui non leggerete sui giornali italiani riguarda un tizio a caso venti-e-qualcos-enne di New York di nome Caleb: è il protagonista di un’enorme storia finita nei possenti trend di TikTok. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando alcune giovani donne, dopo il post di una influencer, hanno scoperto di essere state tutte ghostate (sapete tutti cos'è il ghosting, ma nel caso: ciò che capita quando quello/a con cui ti stai sentendo sparisce di colpo, facendo perdere le sue tracce) dalla stessa persona.
Quella persona era Caleb, che è un impiegato West Elm – una sorta di Poltronesofà statunitense, per capirci – e mostra una marcata tendenza a fregare le ragazze che frequenta. Se però in un primo momento quell’incredibile coincidenza (che probabilità ci sono, in una città di 8 milioni e mezzo di abitanti, che le donne uscite con lo stesso allampanato perditempo si ritrovino online?) è stata fonte di un rito di autocoscienza collettivo riservato a qualche decina di account, presto le cose sono andate fuori controllo: l’influencer newyorkese Kate Glavan, che su TikTok ha poco meno di 100mila follower, ha scoperto che «West Elm Caleb» era uscito con lei il giorno stesso in cui aveva scopato con un’altra ragazza, sempre conosciuta sulla stessa app di dating, Hinge, e ne ha parlato in un video.
Eh vabbè, direte voi, il solito stronzo. Sì, stronzo di certo, ma non il solito, perché la sorte aveva in serbo per lui un trattamento assai insolito: da quel momento la vicenda di Caleb è diventata virale entrando nei trend di TiktTok, è stata amplificata e rideclinata dai potenti algoritmi della piattaforma, e dopo poco decine di migliaia di giovani donne hanno iniziato a condividere brevi video di denuncia dedicati ai veri o presunti «West Elm Caleb» della loro città.
Nel mentre il vero Caleb ha visto diffuso a un pubblico di centinaia di migliaia di persone indignate il suo profilo Linkedin con nome e cognome, la sua sede di lavoro e il quartiere in cui abita. Molt* hanno chiesto che venga licenziato, chiamando anche nello showroom in cui lavora, altr* pretendono di vederlo “solo” segnato a vita per i suoi comportamenti (che secondo le storie hanno compreso anche l’invio non richiesto di sue foto intime).
Qualche ora dopo, accortasi di cosa aveva involontariamente creato, Glavan è tornata sulla vicenda con un altro post, dove nega di aver doxxato Caleb (di cui dice: «Penso che sia terribile con gli appuntamenti, ma non credo che fargli perdere il lavoro renda giustizia a nessuno») e se l’è presa con i media e i brand che hanno capitalizzato sulla storia per prendersi un pezzetto della viralità del trend. Ma è stato too little too late, perché nel frattempo West Elm Caleb era entrato a far parte dello Zeitgeist impazzito della cultura social, e aveva generato infiniti spin-off.
West Elm Caleb Tiktok is the natural next step after true crime Tiktok. We're seeing women piece together stories about getting gaslit, ghosted and dick pic'd by the same guy (threading some of my faves if you care to watch 👇) pic.twitter.com/igVty1qWm8
— Claire Hubble (@byclairehubble) January 20, 2022
Quello del “passo indietro” è, in realtà, un tema ricorrente nelle reazioni degli influencer ai trend da loro propiziati che finiscono fuori controllo, facendo danni: se qualcuno prende il mio contenuto per organizzare torce e forconi, io non posso farci niente, dice grosso modo la linea difensiva standard.
Secondo il giornalista esperto di cultura digitale Hussein Kesvani, in effetti una bella fetta di colpa ce l'hanno anche i giornali, e in generale chi pubblica giornalismo che rincorre la viralità delle piattaforme social, «specie quella che indirizza i discorsi e le conversazioni».
Senza contare che, banalmente, la prima responsabilità è proprio di TikTok, che secondo il giornalista Ryan Broderick (e io proprio non vedo come non essere d’accordo) «ha costruito una macchina per la caccia alle streghe e non gli frega un cazzo di cosa ci fanno le persone», finché gli permette di massimizzare i guadagni. Soltanto negli ultimi mesi, sulla piattaforma di proprietà cinese gli utenti hanno preso di mira un tizio che fa video dedicati ai treni inglesi (sì, hai letto bene), cercando di provare il suo presunto autismo, indagato su Couch Guy (qui breve recap della storia) per sospettato tradimento della sua fidanzata e accusato una donna trans andata virale con un balletto di essere in realtà un’assassina.
Secondo Vox, testata che pure ha pubblicato diversi pezzi di cosiddetto debunking sul panico da cancel culture e affini, dovremmo smetterla di cancellare le persone, perché «sta rendendo il mondo un posto più di merda».
Davanti a tutto questo, dunque, che si può dire? Che la cancel culture non esiste? Che i social non sono il problema? Che le piattaforme hanno finalmente passato il microfono agli ultimi, e chi se ne lamenta è un privilegiato? Se c’è una cosa che questa strana epoca che stiamo vivendo ci ha insegnato, è che la semplicità e la superficialità che ne dominano la comunicazione non bastano per spiegarla, né tantomeno per capirla.
Nel mondo di oggi, quella di West Elm Caleb non è una condizione che si può liquidare con due slogan per accumulare like e schierarsi. Nemmeno in presenza di evidenti stronzi come lui.
E ora, novità: #CultureWarsMeets ⬇
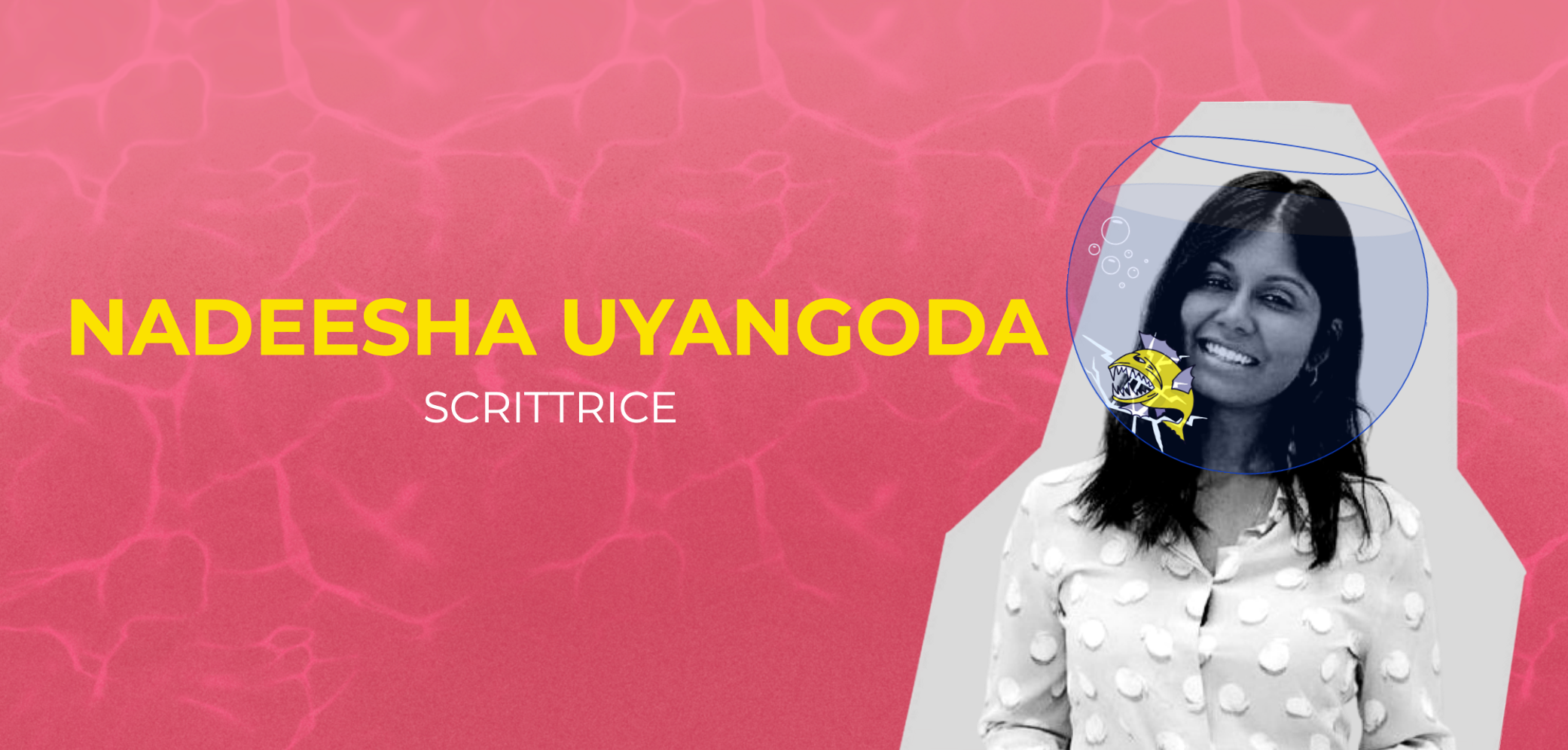
Nell‘ultima puntata, per chi l’ha letta, dicevo che tutto questo ampio e nobile discorso sulla cultura di questi anni non funziona – e, francamente, è anche un po’ noioso – se lo faccio sempre da solo. Essendo di parola, sono passato ai fatti: nella nuova rubrica (per ora non fissa, ma arriveranno novità) #CultureWarsMeets trovate chiacchierate sui temi di questa newsletter con persone titolate a parlarne, o di cui è interessante sentire il parere.
Sono quindi molto, molto contento di cominciare con Nadeesha Uyangoda, l’autrice di un bel libro che dovreste leggere, L’unica persona nera nella stanza (66thand2nd), che parla di razzismo e di appartenenze nell’Italia del 2022.
⪢ Del tuo libro L’unica persona nera nella stanza si è parlato molto, e giustamente: riesci a descrivere cosa significa “essere minoranza” in una società con estrema precisione e capacità letteraria. Perché l’Italia è ancora così indietro sotto il profilo dell’inclusione?
Penso che per comprendere lo scenario italiano dobbiamo mantenere lo sguardo sulla storia – del colonialismo, del razzismo e dell’antisemitismo – e allo stesso tempo non dobbiamo perdere di vista il quadro contemporaneo, tanto nazionale quanto globale, dei razzismi senza razza. La diffusa opinione che la questione razziale sia estranea alla società italiana permea il modo in cui in Italia si parla di razza e razzismo, una maniera che altrove — in Paesi la cui storia di schiavitù, segregazione e imperialismo è percepita come reale e brutale — non sarebbe accettabile.
L’arretratezza italiana rispetto all’inclusione ha quindi secondo me anche a che fare con la scarsa consapevolezza del ruolo della categoria razza nelle società contemporanee, cosa che contribuisce a processi di razzializzazione (insieme ad altre categorie quali classe, varianti di genere e orientamento sessuale), costruendo differenze volte a confermare l’inferiorità di alcune identità.
⪢ In un'intervista recente hai detto una cosa secondo me molto bella, su cui mi sono fermato a riflettere: «La verà libertà è non pensare alla propria identità». Però questo, per certi versi, è proprio l’antitesi dell'intersezionalità di Kimberlé Crenshaw, oggi così popolare nell'attivismo: significa che in realtà identity politics e universalismo possono trovare una sintesi, secondo te?
Quando Obama ha vinto le presidenziali, alcuni osservatori hanno sostenuto che gli Stati Uniti si avviavano a essere una società post-razziale (poi lo stesso Obama sarebbe ritornato sul tema nel suo discorso di commiato). In realtà non c’è bisogno nemmeno di citare George Floyd e gli eventi più recenti per dedurre che si trattava di un mito. Ecco, l’ho presa alla larga per dire che l’identità è come la categoria razza: l’una e l’altra non esistono nel testo – e non pensarle in termini strutturanti sarebbe liberatorio – eppure continuano a lavorare nel sottotesto; eppure, dire che viviamo in un mondo post-identitario significa negare che l’identità contribuisca alla segregazione abitativa, alla sessualizzazione di alcuni lavori e alla razzializzazione di altri, all’accesso a risorse od opportunità.
⪢ Nel grande dibattito sulle seconde generazioni e il razzismo “sistemico“ di cui sono vittime in Italia, c'è una legge che secondo te il parlamento dovrebbe approvare subito? Il primo pensiero va sempre allo ius soli, ma c'è qualcos'altro che ci stiamo perdendo?
La riforma della cittadinanza è la più urgente che mi viene in mente. Accennavo prima alla sessualizzazione e alla razzializzazione del lavoro — e questo in Italia è avvenuto anche attraverso la selettività di alcune politiche migratorie (penso alla questione delle badanti, dell’economia dell'affetto): mi pare un problema piuttosto urgente, soprattutto date le sfide che ha posto la pandemia nella tutela di questi lavoratori.
Recentemente, poi, cercando nuove parole per il podcast Sulla Razza, mi sono soffermata sul concetto di reparations, un dibattito che in Italia non è mai stato – mi pare – lontanamente popolare quanto nel mondo angloamericano, anche per le ragioni di cui dicevamo prima. Questo mi ha portato a riflettere sul fatto che, se il colonialismo non è mai stato del tutto assente dall’immaginario comune, la rimozione più importante è avvenuta nella memoria pubblica, attraverso il silenzio delle istituzioni. Non che questo punto possa, o debba, avere un risvolto a livello legislativo; ma che necessiti di una presa di posizione istituzionale, sì.
⪢ Di recente su Twitter, in uno di quegli estenuanti shitstorm che ci si trova, si è discusso di una ragazza bianca fotografata a una manifestazione pro-ddl Zan con un cartello che recita «il tempo del potere maschio, etero, cis, non disabile e bianco è finito». Ovviamente la formulazione è adeguata allo strumento e al contesto, ma vedendolo ho pensato: prima di pensionare il potere cisgender, andrebbe detto che in Italia non è ancora stato nemmeno avviato un discorso condiviso sui crimini del colonialismo fascista, per dirne una. Una retorica e un approccio del genere non rischia di rendere tutto un dialogo fra sordi, anche dove magari ci sarebbe qualcuno disposto a sentire o imparare?
È una domanda insidiosa. Nel senso che ritengo entrambe le questioni a rischio di retorica. Ho detto spesso che per me dichiararsi intersezionali è un’affermazione che afferisce all’individualità di una persona e non a come agisce all’interno di una comunità: l’intersezionalità è una categoria che definisce un’identità o, piuttosto, una categoria che caratterizza un certo tipo di lotta? Non so se mi sono spiegata… Dall’altra parte c’è la rimozione del passato coloniale, una pratica che ha accomunato molti degli Stati colonizzatori con la caduta degli imperi coloniali. Se è innegabile la tardiva decolonizzazione degli studi storici sul colonialismo italiano, dobbiamo secondo me porci delle domande anche sulle cause — e non solo sulle conseguenza — della strana amnesia italiana. E queste cause riguardano la creazione di un’identità nazionale, la costruzione della bianchezza e della virilità degli italiani, la presenza esigua (almeno fino a un certo punto) di soggetti provenienti dalle ex colonie.
Detto questo e messa da parte la retorica, potremmo soffermarci sul legame che effettivamente sussiste tra il potere del maschio etero, bianco, eccetera, il colonialismo e le moderne dinamiche razziali, di genere o di classe. Mi pare che questo legame emerga molto chiaramente in Femonazionalismo, di Sara Farris.
Altre news dal fronte
- Il consiglio scolastico della contea di McMinn, in Tennessee, ha votato per rimuovere da ogni corso scolastico Maus, la graphic novel di Art Spiegelman sulla Shoah premiata col Pulitzer. Il voto, avvenuto all’unanimità, ha citato le scene di «nudità» e «le imprecazioni» presenti nel libro come motivi per proibirne l”inserimento nei programmi. Un ulteriore segnale del fatto che la cosiddetta cancel culture è un virus pandemico, che non appartiene a un solo gruppo o a una sola corrente ideologica, ma è un malanno culturale che riguarda l’epoca in cui viviamo. Troppo spesso si legge polemicamente, in post di parte, della presunta «vera cancel culture»: ma non ce n’è una vera e una finta (se togliamo le evidenti e copiose fesserie di cui si legge su alcuni grandi giornali, certo), e considerare colpevole solo una parte politica per scagionare la propria può rassicurare, ma non aiuta;

- Gli schwa degli altri: Reuters ha messo insieme uno speciale molto curato – anche sotto il profilo grafico – su come le lingue del mondo stanno interagendo con le nuove istanze di rappresentanza linguistica;

- Si è parlato parecchio della storia, circolata soprattutto sui media di destra o apertamente cialtroni (spesso le due cose coincidono, purtroppo), dell’insegnante della California licenziata per non aver miagolato a uno studente che «si identifica come gatto». Ho due problemi con questa storia, al di là dell’evidente ridancianità che scatena: la prima è che, anche fosse vera, ha comunque poco a che fare con le vicende di persone che sono molto più numerose e, beh, non si sentono gatti; la seconda è che pare non del tutto vera, dato che la stessa insegnante ha detto di essere stata richiamata dai dirigenti scolastici (cosa che sarebbe già pazzesca, ovviamente);

- Mars, la società che produce le celebri caramelle M&M’s, ha fatto sapere di aver ridisegnato l’aspetto e i caratteri dei personaggi che le rappresentano, in senso più «inclusivo». Ci sarebbero un po' di cose da dire, a partire dall’abuso sempre più quotidiano della parola inclusivo, ma sono certo che siete già tutti a fare conoscenza coi nuovi M&M’s.
– That’s All, Folks! –
Se questa edizione ti è piaciuta, car*, mandala un po’ in giro (c’è anche in formato web in archivio) e soprattutto costringi tua nonna a iscriversi mandandole questo link. Guarda che ci conto, eh.
A venerdì prossimo!









